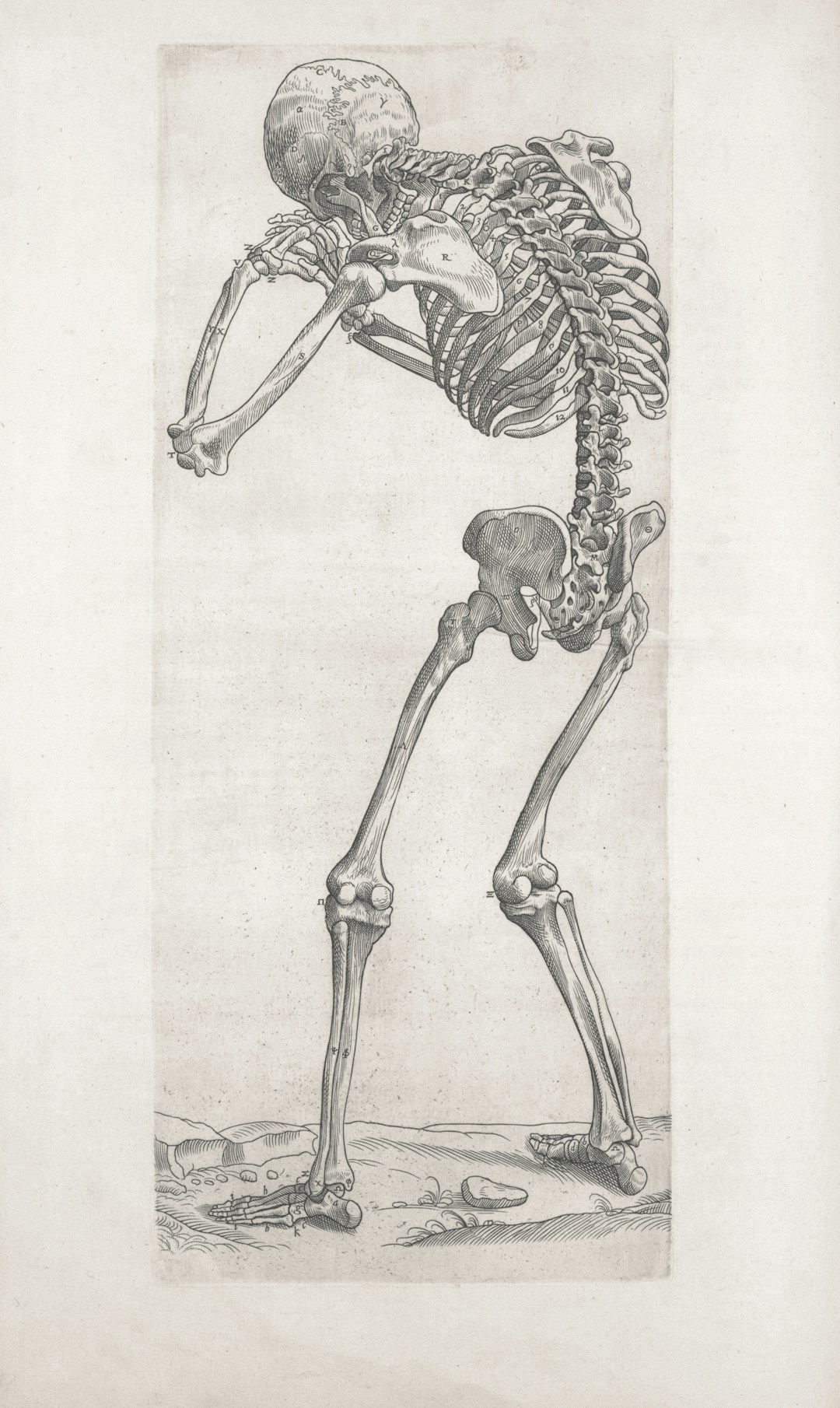4
Nel 1954, circa una decina di anni dopo la Liberazione, la casa editrice Einaudi sentì la necessità di pubblicare le ultime testimonianze di donne e uomini di tutta Europa giustiziati nel nome della Resistenza. L’antologia, curata da Pietro Malvezzi e Giovanni Pirelli e intitolata Lettere di condannati a morte della Resistenza europea, riporta integralmente le lettere di oltre trecento partigiani, suddividendole in base alla nazionalità di quest’ultimi. Si tratta di un caposaldo della letteratura e dell’identità europea che ci ricorda, proprio nell’ottantesimo anniversario di quel 25 aprile 1945, quanto fossero simili i sentimenti e le reazioni dei fautori di un’Europa libera al momento del grande salto verso la morte. Considerato che la società in cui viviamo è ormai totalmente globalizzata, capitalista e ,perciò, fortemente individualista, al giorno d’oggi potrebbe stupire come persone così diverse per provenienza, sesso, età ed estrazione sociale si siano mosse per una medesima causa. Ancora più stupefacente è notare che nelle loro epistole-testamento vengono immortalati concetti, speranze e paure comuni, che vale la pena riassumere per riflettere sulla possibilità, ancora oggi, di raggiungere uno spirito unitario e comunitario europeo.
Prima di tutto, quando si parla di sentimenti di fronte ad un plotone d’esecuzione, l’ultimo pensiero non può che correre verso i propri cari, i genitori – molto più di frequente verso la cara mamma, vuoi perché i padri spesso son già morti, vuoi perché son assenti, vuoi perché, come faceva notare Pasolini, il rapporto con tutto ciò che è paterno è sempre ostico. Ogni figlio avverte pesantemente tutto ciò che c’è di sbagliato nel lasciare il mondo terreno prima di chi gli diede la vita. Pertanto, pressoché tutti i condannati si affrettano a rassicurare babbo e mamma, quasi a giustificare la loro prematura dipartita, di cui nessuno deve rattristarsi né pentirsi, in quanto atto di sacrificio verso il futuro. Se alcuni, per lasciare un ricordo piacevole ed esorcizzare le lacrime, rievocano nelle lettere i momenti felici della loro breve gioventù, la maggior parte degli eroi partigiani volgono lo sguardo al futuro, consapevoli e fieri del fatto che la loro morte non sarà vana, che la loro memoria non decadrà nell’oblio e che continueranno a vivere nelle vite dei tanti che hanno salvato grazie alla loro morte.
In molte lettere si ribadisce un senso del dovere che porta anche i più giovani e i più attaccati alla vita a compiere un gesto che non lascia alcuna via di ritorno. Eppure – Ungaretti già lo constatava con amaro stupore durante quella notte del 23 dicembre 1915, resa celebre dai suoi versi in Veglia - è proprio nell’orrore della morte imminente che si risveglia questo attaccamento alla vita, coniugandosi quasi in un’ansia di compiere il proprio necessario sacrificio per la libertà e per la vita di chi rimarrà.
Lasciamo che sia il messaggio che Marguerite Bervoets, insegnante e poetessa belga, rivolge ad un’amica a spiegare meglio tale slancio vitalistico:
[...] Vi si dirà che sono morta inutilmente, stupidamente, da esaltata. Sarà la verità... storica. Ve ne sarà un’altra. Sono morta per attestare che si può amare follemente la vita e insieme accettare una morte necessaria.
A voi incomberà il dovere di addolcire il dolore di mia madre. Ditele che sono caduta perché il cielo del Belgio sia più puro, perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l’ho tanto voluto io stessa: che non rimpiango nulla, malgrado tutto.
Emblematico, in tal senso, è anche l’ultimo appello di Giordano Cavestro, uno dei più giovani partigiani che la nostra città (Parma) ricordi:
Cari compagni,
ora tocca a noi.
Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi compagni caduti per la salvezza e per la gloria d’Italia.
Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio, ma l’idea vivrà nel futuro, luminosa, grande e bella.
Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime possibile.
Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme così buone e le ragazze così care.
La mia giovinezza è spezzata ma sono sicuro che servirà da esempio.
Sui nostri corpi si farà il grande faro della Libertà.
Cara mamma e cari tutti,
purtroppo il Destino ha scelto me ed altri disgraziati per sfogare la rabbia fascista. Non preoccupatevi tanto e rassegnatevi al più presto della mia perdita.
Io sono calmo.
Vostro Giordano
L’ultima parte della lettera del partigiano Mirko – questo il nome di battaglia di Cavestro – ci porta ad affrontare un altro tema cardinale: la fede. Beninteso, la fede in senso lato, che sia in Dio, o nel Destino, o nella Patria. Non tutti sono religiosi, soprattutto i partigiani ispirati dal ferreo ateismo e anticlericalismo tipico delle idee socialiste e comuniste; eppure, sono proprio costoro ad avvertire il bisogno della religione, non tanto per sé, quanto piuttosto come mezzo di conforto per gli altri. Persino negli ultimi istanti di vita, tutti i condannati indossano, come una veste rituale, un’inaspettata calma, nell’altruistico gesto di provocare il minor dolore possibile ai propri parenti ed amici. Per questo anche gli atei si rivolgono a Dio; per questo anche i più pessimisti reprimono ogni afflato nichilista; per questo anche i più seriosi diventano acrobati di ironia. Tutti, inoltre, tentano di indorare la pillola amara ai propri vicini attraverso due linee stilistiche antitetiche, ma ambedue efficaci: la prima punta tutto sull’essenzialità del messaggio, sul riportare la notizia della sentenza di morte nel modo quanto più asciutto e scarno possibile, quasi fosse un bollettino scientifico; la seconda, al contrario, trova un’espressione più alta, più spirituale e più poetica. E spesso la lunghezza delle epistole stesse risponde a tali esigenze formali, come si può concludere dalle ultime parole dello studente tedesco Walter Klingenbeck, dalla cui laconicità traspare quasi noncuranza verso la sua tragica fine:
Caro Johnny,
Poco fa ho saputo che ti è stata concessa la grazia. La mia domanda è stata comunque respinta. Ergo bisogna andarsene. Non prenderla troppo sul tragico. Tu te la sei cavata. Questo è già molto. Ho appena ricevuto i sacramenti e ora sono tranquillissimo.
Se vuoi fare qualcosa per me, di’ un paio di paternoster.
Ciao Walter
C’è anche chi, nonostante la scarsa possibilità di istruirsi e nonostante la poca dimestichezza con le parole, ha addirittura dato origine a poesie quanto mai ispirate e degne dell’eroica azione della Resistenza, come l’operaio bulgaro Nikola Vapcarov:
A mia moglie.
Talvolta io verrò mentre tu dormi
Come un ospite inatteso e lontano.
Tu non mi lasciare fuori sulla strada,
Non chiudere a chiave la tua porta.
Entrerò in silenzio, siederò umilmente,
Guarderò nel buio, cercando di vederti
E quando sarò sazio di guardarti
Ti darò un bacio e me ne andrò.
La lotta è implacabile, spietata.
La lotta, come dicono, è epica.
Io sono caduto. Altri prenderà il mio posto.
Cosa conta qui una persona?
Ti fucilano e dopo che t’han ucciso, i vermi...
Questo è tanto semplice e logico;
Ma nella tempesta ti saremo ancora accanto,
O popolo mio, perché ti volemmo bene.
Molto altro potremmo dedurre dalla lettura dell’ intera raccolta -ragion per cui vi invitiamo a sfogliare in autonomia il resto del tomo- ma non buttiamo troppa carne al fuoco. Fermiamoci a riflettere sul presente e su un passato relativamente recente.
Dunque, circa ottant’anni fa, donne e uomini come noi, diversi ma in fondo uguali, si sono sentiti uniti nell’urgenza di non poter più tollerare che la liberà, i diritti, l’aria della vita venisse loro tolta dall’atrocità della guerra. Le varie modalità in cui la Resistenza si espresse traevano origine da uno stesso sentimento di amore, mai di odio, nemmeno verso i nemici, verso i loro stessi assassini, a cui il perdono viene concesso in molte epistole (non tanto alla luce di una pietà cristiana, quanto per un senso di comprensione e fiducia nei confronti dell’umanità).
Che riecheggino sempre quegli ultimi versi di Vapcarov, che ripetiamo ancora:
Ma nella tempesta ti saremo ancora accanto,
O popolo mio, perché ti volemmo bene.
Eppure, malgrado i tempi atroci che concorrono oggigiorno, dov’è finito quell’attaccamento alla vita? Dov'è quell’amore verso tutto e verso tutti? Lo si ritrova nei bambini di Gaza che, dopo una notte di bombardamenti, cantano sulle note di “Bella Ciao”. Ma qui, in Europa, pare drammatico notare quanto siamo anestetizzati, quanto siamo coglioni a non accorgerci dell’aria che ci stiamo risucchiando da soli, non provando nemmeno a lottare quando la ventata di estrema destra che ci investe conduce a politiche folli, quali il fantomatico decreto sicurezza; quando conduce alla soppressione di molti diritti umani e costituzionali; quando alimenta l’odio e la violenza; quando ritornano i fascismi mascherati sotto altri termini.
Perché si è tutto sciupato?
Se nelle lettere d’addio della Resistenza europea rimbombano sovente le richieste di perdono ai destinatari per la loro prematura morte, ora siamo noi posteri a dover chiedere loro perdono.
Perdono, per la morte civile che ci stiamo procurando da soli.
Perdono, per la Loro memoria che stiamo trascurando.
Perdono, per la nostra indifferenza, che non ci rende affatto degni di Loro.
Perdono, per aver diviso un’Europa che Loro avevano unito col sigillo del Loro sangue e delle Loro parole.
Autore
@Niccolò Delsoldato
Potrebbero interessarti:




Dello stesso autore:

/w=1920,quality=90,fit=scale-down)