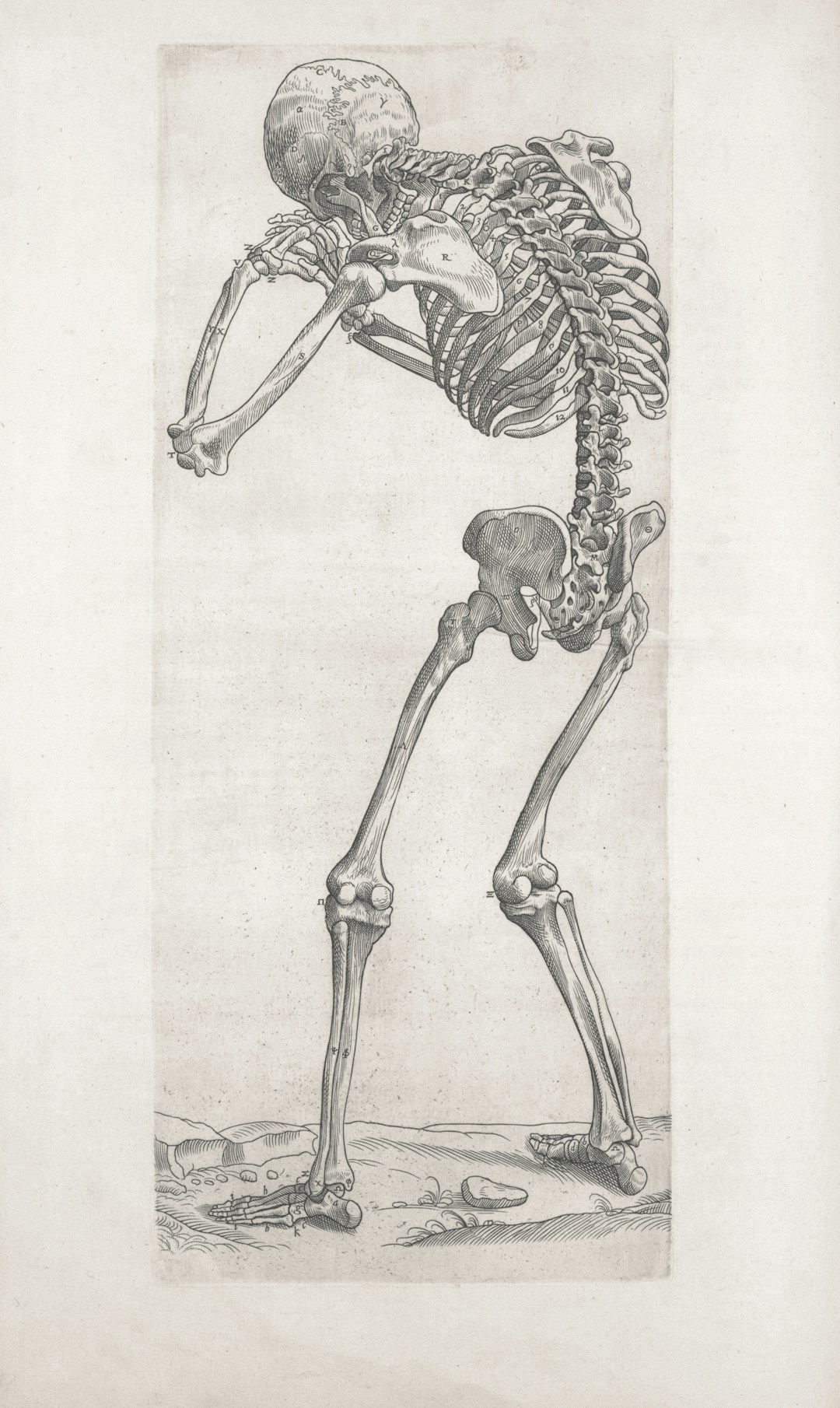Parma, 27 giugno 2025 – Una festa di comunità , certo, ma anche un laboratorio di pensiero e cittadinanza attiva. Alla Casa nel Parco, nel quartiere San Leonardo, la serata organizzata da On-Off, Tracchete Aps e Cooperativa Sociale Ecole ha riunito professionisti, educatori, amministratori e attivisti per parlare con e dei giovani. E per ascoltarli.
In una festa che ha previsto due giorni di attività educative, culturali, laboratoriali e ludiche-tutte condotte lungo una linea di tematiche virtuose e di grandissimo interesse per le nuove generazioni- anche Punto e Virgola ha avuto l'occasione di creare un dibattito volto alla messa in gioco di riflessioni, punti di vista e diverse fra le più interessanti voci in materia di futuro e benessere giovanile, a livello cittadino, nazionale ed europeo.
Ma prima di lasciare la parola a queste testimonianze, è bene capire il significato complessivo della festa, il suo obiettivo, ed il valore del luogo dove essa si svolge ogni anno.
Luca Esposito, direttore dell’associazione On-Off, ha ricordato come questa realtà operi da oltre undici anni nel quartiere, costruendo relazioni e iniziative che intrecciano lavoro, innovazione e comunità. La festa, anche quest’anno, nasce da questo legame forte e duraturo con il territorio.
Ma Casa nel Parco, spiega Lorenzo Menozzi di Tracchete Aps, è molto più di un centro giovani:
«È uno spazio educativo che si fonda sul learning by doing, dove si coltiva il verde ma anche l’artigianato, il compostaggio, l’arte e il pensiero. È sede di un FabLab, di On-Off, e di tante progettualità ibride. È un luogo multiculturale e multilingue, dove i giovani possono esprimersi, formarsi e contaminarsi. È uno spazio per fare. E per essere.»
In questa cornice, ha preso forma un talk collettivo condotto da Punto e Virgola, con sei ospiti e un pubblico partecipe. A chiudere, un dibattito dedicato alla salute mentale.
GLI OSPITI E LE DOMANDE
Prof. Simone Baglioni: «L’Europa offre opportunità, ma restano per pochi»
Ordinario di Sociologia all’Università di Parma, ha insegnato in numerose università europee. Esperto di politiche pubbliche, terzo settore, disuguaglianze sociali e cittadinanza attiva. Dirige progetti internazionali su giovani, lavoro e inclusione.
«La cultura non si trasmette come un’eredità, si conquista con l’esercizio e la fatica.» — Antonio Gramsci
Domanda:
Professore, partiamo dall’Europa: cosa sta facendo oggi, concretamente, l’Unione Europea per i giovani, e cosa invece manca nei suoi orizzonti di intervento?
Alla luce del suo lavoro accademico e di ricerca, come si può oggi promuovere una scienza sociale che non parli solo a sé stessa, ma dialoghi davvero con la società, in particolare con i giovani? In un contesto in cui le disuguaglianze sembrano diventare strutturali e la ricerca rischia di diventare autoreferenziale, qual è — se esiste — il ruolo di un’accademia “civica”?
«Vengo spesso a Casa nel Parco con i miei colleghi per fare ricerca, perché questi sono luoghi vivi, in cui si respira cittadinanza attiva. L’Unione Europea ha fatto molti passi avanti sul tema delle opportunità per i giovani: ha investito in reti universitarie, borse di mobilità, scambi culturali. Penso ai progetti Erasmus, ma anche ai nuovi campus europei che uniscono nove atenei in un’unica offerta formativa. Tuttavia, il limite è l’accessibilità: queste opportunità sono spesso pensate per chi ha già strumenti culturali e sociali solidi. Dobbiamo democratizzare l’accesso.
L’accademia, dal canto suo, rischia di parlarsi addosso. La scienza sociale, se vuole incidere davvero, deve uscire dalle aule, costruire ponti con la cittadinanza e, in particolare, con i giovani. Una “accademia civica” ha il dovere di non limitarsi all’analisi, ma di contribuire al cambiamento, contrastando l’autoreferenzialità e dialogando con le esperienze concrete, come quelle che nascono qui.»
Andrea Scannavino: «Lo sport è diritto, non lusso»
Educatore sportivo, fondatore di PAZ – All Inclusive Sport, progetto nato per rendere accessibile lo sport a giovani in condizione di marginalità economica e sociale. Collabora con la cooperativa sociale Ecole.
«Lo sport insegna che per ogni traguardo raggiunto c’è sempre un nuovo punto di partenza.» — Giampiero Boniperti
Domanda:
Nel contesto urbano di Parma, qual è oggi — secondo lei — il “punto di partenza” per costruire uno sport davvero inclusivo, accessibile a tutti, e non riservato a chi può permettersi quote associative, attrezzature e tempo libero?
Come nasce PAZ – All Inclusive Sport, e che tipo di trasformazione sociale e culturale vuole generare attraverso lo sport?
Cosa significa, per voi, fare sport “dal basso”?
«Lo sport, per essere davvero inclusivo, deve essere prima di tutto accessibile. Non può dipendere da quanto una famiglia può pagare. PAZ – All Inclusive Sport nasce proprio per questo: nel 2010 abbiamo iniziato lavorando con richiedenti asilo e rifugiati, per dare loro non solo un’attività sportiva, ma una rete di supporto, relazioni, salute. Poi siamo cresciuti: oggi lavoriamo con bambini, con persone nello spettro autistico, con realtà femminili. Il nostro centro sportivo è diventato un presidio sociale.
Viviamo però in una cultura che confonde lo sport con la competizione esasperata. Invece lo sport deve essere uno strumento educativo. Insegna a stare nelle regole, ad affrontare le sconfitte, ad avere rispetto per sé e per gli altri. Fare sport “dal basso” significa creare spazi che partano dai bisogni reali delle persone, senza escludere nessuno.»
Giuliana Nico: «L’interpretazione senza emozione è un’aggressione»
Educatrice e formatrice con oltre vent’anni di esperienza in contesti scolastici e di strada. Si occupa di dispersione scolastica, ascolto attivo e percorsi educativi personalizzati. Crede nell’educazione come strumento di giustizia.
«Ogni forma di violenza è un grido di chi non è stato ascoltato abbastanza.» — Citazione orientale
Domanda:
Nell’educazione con adolescenti “difficili” si percepisce spesso una rabbia che nasce più dall’invisibilità che dalla devianza.
Come possiamo — da educatori, cittadini, istituzioni — costruire strumenti di ascolto reale, che restituiscano ai ragazzi voce, dignità e legami?
Che cosa ha imparato lei, negli anni, sul silenzio e sulla rabbia di chi non si sente visto?
«La rabbia dei ragazzi non è quasi mai una forma di devianza. È una forma di dolore. Di invisibilità. Di assenza di sguardi autentici. Spesso educatori, cittadini, istituzioni osservano i giovani con un filtro analitico, ma senza reale coinvolgimento. E l’interpretazione senza emozione, come dico spesso, diventa una forma di aggressione.
La sfida educativa oggi è costruire relazioni vere, che non giudichino ma accompagnino. Occasioni come questa festa sono importanti proprio perché creano spazi di ascolto, dove i ragazzi possono essere visti, riconosciuti. Educare significa ascoltare anche quando non si è d’accordo, e soprattutto quando il silenzio urla più della voce.»
Beatrice Aimi: «Il rischio è creare spazi che escludono proprio chi ha più bisogno»
Consigliera alle politiche giovanili del Comune di Parma. Coordina progetti e spazi per under 35 come Il Punto, centro dedicato alla partecipazione e al benessere giovanile. Ha una lunga esperienza nelle politiche educative.
«I giovani non sono il futuro: sono il presente trattato come un problema futuro.» — Francesco Stoppa
Domanda:
Come evitare che spazi come Il Punto si rivolgano solo ai “giovani partecipanti”, lasciando fuori quelli che non votano, non frequentano i circuiti istituzionali, non parlano la lingua dei bandi?
Quali strategie state adottando per raggiungere quei giovani “non rappresentati”?
Che ruolo ha in tutto questo la questione della salute mentale?
«Quando abbiamo pensato a Il Punto, lo abbiamo voluto nel cuore della città proprio per renderlo visibile e accessibile a tutti. Ma sappiamo che lo spazio fisico non basta. Il rischio è quello di parlare solo ai giovani che già partecipano, che hanno strumenti culturali, che sanno leggere un bando.
Per questo il nostro lavoro si concentra molto sulla costruzione di reti: con educatori di strada, scuole, associazioni di quartiere. Abbiamo lavorato a questionari, momenti di ascolto, colloqui, per capire davvero i bisogni dei giovani “meno strutturati”. E su questo costruire opportunità ad hoc.
La salute mentale è centrale. Non possiamo parlare di opportunità se non riconosciamo prima il disagio diffuso. Troppi giovani si sentono schiacciati da aspettative, performance, solitudini. Dobbiamo creare spazi che non chiedano subito di “fare”, ma prima di tutto permettano di “essere”.»
Victoria Oluboyo: «Fare politica è portare il dissenso dove conta»
Classe 1994, consigliera comunale a Parma e parte della direzione nazionale del Partito Democratico. Si batte per i diritti civili, contro le discriminazioni, per la rappresentanza delle persone LGBTQIA+ e radicalizzate.
Domanda:
Come ti sei sentita entrare da giovane nel mondo della politica partitica?
Con il mondo che sembra tornare indietro e l'approvazione del Ddl sicurezza, ti sei sentita frenata nelle battaglie che porti avanti o, al contrario, questo ti ha motivata?
«Ci tengo a dire innanzitutto, con orgoglio, che sono cresciuta anche io frequentando Casa nel Parco.
Entrare in consiglio comunale nel 2022 è stato un momento forte, perché mi ha permesso di portare dentro le istituzioni battaglie che prima vivevo nelle piazze. Non è facile: la burocrazia a volte sembra voler soffocare il cambiamento. Ma proprio per questo è ancora più importante esserci.
Negli ultimi anni ho sentito forte la frustrazione. Penso al fallimento del Ddl Zan, ai festeggiamenti del governo, alla repressione del dissenso. Ma non possiamo arrenderci. I diritti civili e quelli sociali devono andare di pari passo. Anche chi non è coinvolto direttamente in una battaglia deve sostenerla, se crede nella giustizia.
La politica ha bisogno di giovani, anche se spesso li respinge. Ma dobbiamo esserci. Anche quando costa. Anche quando fa paura.»
Eleonora Urbanetto: «Il Consiglio Locale Giovani è il nostro esperimento di democrazia»
Portavoce del Consiglio Locale Giovani, nato nel 2020 durante la candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027. Il CLG rappresenta un esperimento concreto di cittadinanza attiva giovanile.
«Ascoltare davvero è dare a un’altra persona il permesso di essere se stessa.» — Rachel Naomi Remen
Domanda:
Quali sono, secondo voi, le iniziative che più hanno saputo parlare davvero ai giovani, creando partecipazione e identità comune?
E in che cosa, oggi, sentite di “rappresentarli”?
Quali difficoltà, ma anche quali responsabilità comporta avere voce e visibilità in un tempo in cui la partecipazione giovanile è spesso frammentata?
«Il Consiglio Locale Giovani nasce come eredità viva del percorso per Parma 2027. È un gruppo eterogeneo, che si è dato struttura e regole, ma che ha voluto mantenere la memoria come bussola. Rappresentare i giovani significa prima di tutto uscire dalla propria bolla. E ascoltare.
Abbiamo discusso a lungo per creare uno statuto che parlasse a tutti. È stato difficile, ma necessario. Ognuno di noi ha portato esperienze diverse: chi viene dall’attivismo, chi dall’associazionismo, chi semplicemente aveva voglia di cambiare qualcosa. È questa diversità che dà forza al gruppo. Ed è proprio a ragione di questa diversità che scrivere il nostro statuto e scrivere anche il nostro manifesto è stato un esercizio di democrazia molto,molto difficile.
Prima si parlava di come intercettare i bisogni di tutti i giovani, anche quelli con minori opportunità. E certamente uno dei modi per rappresentare veramente tutte le categorie di giovani è quello di uscire dalla nostra bolla e conoscere nuove idee, partecipare a eventi, mettersi sempre in un ascolto vivo e aperto. Ed è proprio per questo che che è stato creato il Consiglio locale dei giovani affinché resti per sempre.»
DEBATE FINALE – Salute mentale, tra stigma e realtà
Dato il grande interesse per la salute mentale- un tema intrinseco al DNA di Punto e Virgola, quasi programmatico, considerato che non a caso il giornale porta il nome di un simbolo della lotta alla depressione- non potevamo stuzzicare i nostri ospiti con una riflessione critica sull’argomento, partendo da un testo realizzato dal nostro Riccardo Maradini, che ci teniamo a riportare e valorizzare integralmente:
Secondo l'ultimo rapporto UNICEF 2023 a livello globale 1 adolescente su 7 tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato; tra questi 89 milioni sono ragazzi e 77 milioni sono ragazze. I tassi in percentuale di problemi diagnosticati sono più alti in Medio Oriente e Nord Africa, in Nord America e in Europa Occidentale. L’ansia e la depressione rappresentano il 40% dei disturbi mentali diagnosticati. In alcuni casi il disagio è tale da lasciare i giovani con la sensazione di non avere alternative: il suicidio in Europa occidentale è la seconda causa di morte per i ragazzi tra i 15 e i 19 anni, dopo gli incidenti stradali.
Nel nostro paese prima della pandemia, la prevalenza dei problemi di salute mentale si collocava intorno al 18-20% della popolazione, ovvero tra 1.800.000 e i 2 milioni di persone minorenni. Nel 2019, si stimava che il 16,6% dei ragazzi e delle ragazze fra i 10 e i 19 anni, circa 956.000, soffrissero di problemi di salute mentale, e con una incidenza in aumento con l’età.
Ma ora parliamo dello stigma che attornia le cosiddette “malattie mentali”. La parola stigma, di origine greca, significa marchio, impronta, segno distintivo. È utilizzata in diversi ambiti, dalla botanica alla musica. In particolare, gli esperti di salute mentale individuano con questo termine la discriminazione basata sul pregiudizio nei confronti del malato mentale.
È la condanna sociale, la colpevolizzazione, il sostenere che questi disturbi non hanno rimedio e sono pericolose, e, per chi soffre di questi disturbi come spesso per le loro famiglie significa vergogna, senso di colpa, necessità di isolarsi. O sparire.
Se si ammalano i polmoni, se si ammala il cuore, perché non può ammalarsi un organo tanto più complesso come il cervello? La pazzia, in realtà, è stata districata da tempo in tante distinte malattie: depressione, ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, panico, distimia, anoressia, schizofrenia. Ognuna con una propria diagnosi e con una conseguente terapia.
Vi chiedo di riflettere su questo tipo di realtà, so che non è rosea, ma per superare il male, bisogna imparare a riconoscerlo.
"Perché facciamo ancora fatica ad accettare che anche la mente possa ammalarsi?"
Ecco dunque cosa ne è scaturito…
Giuliana Nico:
«Spesso rimuoviamo ciò che ci fa paura. Pensiamo che il disagio mentale sia qualcosa di lontano da noi. Ma non lo è. È parte della nostra realtà, e negarlo è solo una strategia difensiva. Serve più verità, più coraggio, più umanità.»
Victoria Oluboyo:
«Abbiamo imparato da poco che la mente va curata. Serve parlare, fermarsi, ascoltarsi. I giovani ne sono consapevoli, ma dobbiamo coinvolgere anche gli adulti, che spesso nascondono il dolore sotto il silenzio.»
Eleonora Urbanetto:
«Siamo una generazione fragile, ma consapevole. Riconosciamo le emozioni e i limiti, e vogliamo trasformarli in forza. Vogliamo una vita che tenga insieme produttività e benessere. Senza vergogna. Con rispetto.»
Casa nel Parco: laboratorio di futuro
La festa si è conclusa, ma resta l’eco delle parole. Dove le domande contano quanto le risposte. Dove i giovani non sono il futuro, ma il presente che abita — e costruisce — la città.
La Festa a Casa nel Parco non è stata solo un momento di aggregazione, ma un’occasione preziosa di riflessione collettiva, dove le domande contano quanto le risposte, dove i giovani non sono il futuro, ma il presente. Si è creato un mosaico di voci che, pur diverse, hanno saputo trovare un terreno comune: quello della dignità, dell’ascolto e dell’opportunità.
Parlare di giovani non è mai semplice, ma è necessario. Ancora di più lo è parlare con i giovani. Le parole emerse in questa serata — sulla salute mentale, l’inclusione, la cittadinanza, la politica, l’educazione, lo sport — ci restituiscono un orizzonte di speranza che non è ingenuo, ma determinato.
Non possiamo che concludere con i più ragguardevoli ringraziamenti a chi ha creato lo spazio per questo dialogo, a chi lo ha abitato con pensiero e sincerità, e a chi ha scelto di mettersi in gioco.
Autore
Niccolò Delsoldato
Potrebbero interessarti:




Dello stesso autore:

/w=1920,quality=90,fit=scale-down)




/w=1920,quality=90,fit=scale-down)