4
Lo sentite? Il caldo che arresta anche il tempo?
Se -com’è giusto e sacrosanto- vi trovate già in vacanza, spaparanzati su un costosissimo lettino in riva al mare, prenotato con almeno cinque mesi di anticipo, oppure in qualche località d’alpeggio, nella debole speranza di trovare un refrigerio sempre più effimero, allora probabilmente non sentirete quanto straziante sia la staticità canicolare delle ore che muoiono. Ma nessuna paura: nel giro di qualche giorno anche queste vacanze volgeranno al termine e sarete costretti a fare i conti con l’afa gialla e lenta. Solo a luglio, solo trascorrendolo nella monotonia delle nostre fumose città, possiamo percepire la secca disperazione dell’arrestarsi della caduta dei granelli di sabbia nella clessidra. Davanti a tanto vuoto, nulla possiamo fare se non metterci bocconi, lasciarci assordare dal frinire delle cicale e, finalmente, con un occhio aperto ed uno chiuso perché una goccia di sudore dalla fronte ci è scivolata dentro, metterci a pensare. Pensare a cosa? Bah- che so? - al passato, al bisogno di una doccia fredda, all’amarezza del ritorno dalle vacanze, alla noia del non saper che cazzo fare, essendo impossibile qualsiasi movimento che non sia lo sbatter di ciglia, con ‘sto caldo assassino.
È inevitabile che a luglio ci si senta soli. Soli come ci si può sentire nel mezzo di una festa. Tutti ridono, ballano, cantano e tu, in mezzo alla pista, hai quel momento di distacco in cui ti chiedi: “che cosa ci faccio qui? Che ho a spartire con tutti questi esseri alieni che si divertono?”.
Tutto questo disagio estivo è racchiuso da Giorgio Caproni in pochi, icastici versi, pregni di uno stoicismo contemporaneo che insegna ad adattarci al logos universale:
Sui ferri roventi
dell’estate
si posano mosche e moscerini,
ed io con loro.
Senza rancore,
con pazienza.
Aspetto che passi
anche questa stagione.
Fortunatamente Punto e Virgola ha deciso di rimandare ancora un pochino le vacanze, un po’ perché speriamo di divenire la vostra panacea contro la noia estiva, un po’ perché la scrittura degli articoli e la vostra compagnia ci distraggono dal senso di arida depressione che viene tipicamente in questa stagione, quando cominciamo a riflettere sulla vanità delle attività umane e sulla risibilità delle nostre singole vite a confronto del vasto flusso dei secoli.
E non siamo sicuri che, anche quando saremo in vacanza, non ci porteremo dietro qualche strascico di questa desolazione torrida e urbana.
Ancora una volta ci viene in soccorso la poesia, per spiegare un tale sconcerto umano. Lasciamo parlare per noi il genio poetico di Montale:
Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
schiocchi di merli, frusci di serpi.
nelle crepe del suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano
a sommo di minuscole biche.
osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.
e andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
Dunque, ancora un piccolo sforzo prima di approdare alla nostra “Feria d’agosto”. E non è certo uno sforzo dappoco, dato il tema su cui abbiamo scelto di concentrarci in questo editoriale. Non siamo, infatti, immuni dai riflessi nostalgici e dall’affiorare dei ricordi destati dal solleone. Ragion per cui non potevamo che ragionare in merito alla “Nostalgia”.
Non domandate che cosa sia la nostalgia: ognuno ne dà un significato diverso, che non può esser che il risultato della somma dei ricordi individuali e delle esperienze personali. Tuttavia, alcune di queste accezioni semantiche si possono intravedere nelle etimologie e tramite l’analisi linguistica.
In italiano, la parola nostalgia deriva dall’unione di due termini greci: nostos e algos. Sono due concetti alla radice della cultura occidentale, tanto da comparire fin nei primi versi dell’Odissea:
Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·
πολλῶν δ' ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,
ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.
[L'uomo dai molti modi ispirami, o Musa, che moltissimo
errò, quando distrusse la sacra cittadella di Troia;
e di molti uomini vide le città e conobbe la mente,
e molti dolori egli nel mare soffrì nel proprio animo,
cercando di garantire la propria vita e il ritorno dei compagni.]
Cerchiamo ora, con l’aiuto del dizionario etimologico greco del Chantraine, di capire cosa sta all’origine di questi termini. Saremo brevi e schematici, promettendo di tediarvi il meno possibile.
Ἄλγος (algos): indica la sofferenza, usato spesso nelle sue derivazioni aggettivali nei contesti bellici per indicare il dolore fisico, ma anche il tormento interiore. Il sostantivo deriva molto probabilmente dal verbo ἀλέγω (alego), il cui significato letterale è quello di “tener conto di” / “considerare”. Da questo originario senso sarebbe avvenuto uno slittamento semantico più metaforico, forse in modo eufemistico, andando a definire la “preoccupazione” provocatasi dopo aver tenuto in considerazione un dato fatto. Secondo altre ipotesi, il greco ἀλέγω andrebbe messo in relazione col latino algĕo (= avere freddo), facendo affidamento sull’evoluzione semantica del verbo ῥιγέω (= tremare dal freddo), sebbene l'evoluzione "freddo > brivido > spavento" sia meglio spiegata di "freddo > dolore".
νόστος (nostos): denota il “ritorno” e deriva anche questo da un verbo molto importante nel contesto omerico, specialmente nel poema che racconta il ritorno in patria dell’eroe Odisseo. Il verbo in questione, νέομαι (neomai), che significa “venire” o “tornare”, a seconda dei prefissi che gli sono affibbiati. Eppure, anche per questo termine, l’accezione originaria è duplice: alcuni composti aggettivali di nostos, infatti, hanno a che fare non solo col viaggio, ma anche col raccolto nei campi, il che calza proprio a pennello con il mese di luglio, quando cioè le messi diventano pronte per esser mietute. Per fare un esempio, se a nostos attacchiamo l’avverbio εὖ (eu= bene), ecco che avremo un aggettivo composto adatto a qualificare sia un qualcosa “che permette un ritorno propizio”, come un porto (così era chiamato, riporta Strabone, un porto di Alessandria), sia il nome di un nume tutelare delle macine e del loro buon rendimento. E così, l’aggettivo νόστιμος (nostimos), indica qualcosa che inerisce al ritorno o qualcosa che produce un buon raccolto; perciò, per estensione, nel greco moderno designa qualcosa di “prospero”, “succulento”, ma anche “piacevole”, “elegante”. Il significato originario della radice, però, contiene la nozione di un felice ritorno, di salvezza; in senso attivo il significato sarebbe "salvare". In germanico colleghiamo direttamente il goto gà-nisan (= "essere guarito, salvato"), l’anglosassone genesan (="sfuggire, essere salvato, sopravvivere"). Il ritorno, pertanto, è sempre un punto di approdo salvifico.
Basta, basta, abbiamo finito con la lezione di greco. Ma la lingua è così importante per capire un popolo, che non possiamo non prendere nota di altri interessanti modi in cui il concetto di nostalgia è espresso.
Se per molte culture la nostalgia rappresenta il desiderio inappagato del ritornare, tanto che Ulisse, pur essendo “il più grande avventuriero di tutti i tempi, è anche il più grande nostalgico”, per altre la nostalgia appare come la sofferenza dell’ignoranza: “tu sei lontano, e io non so che ne è di te. Il mio paese è lontano, e io non so cosa succede laggiù” (queste son parole dello scrittore ceco Milan Kundera, che dedicò un intero romanzo alla nostalgia intitolato “L’ignoranza”). In spagnolo, in particolare, añoranza viene dal verbo añorar (= “provare nostalgia”), che viene dal catalano enyorar, a sua volta derivato dal latino ignorare.
Alla luce di tutti questi significati, si deve concludere che il tema della nostalgia è strettamente connesso a quello della memoria e del ricordo. Kundera ci insegna che ogni individuo opera una selezione delle esperienze da ricordare, e che ciò che la mia memoria trattiene può essere diverso da ciò che la tua decide di salvare. Sebbene entrambi abbiamo vissuto la stessa esperienza, ne abbiamo dato un valore e un’importanza differenti, cosicché io potrei ignorare eventi che tu hai invece inserito nel tuo album dei ricordi più cari. Non c’è da farsene un cruccio: come lo stoico Caproni, dobbiamo prenderne atto e adagiarci come le mosche, senza rancore e con pazienza. La nostra memoria ha dei percorsi strani ed inesorabili, incomprensibili. Anche i dettagli di una medesima storia possono essere completamente differenti, a seconda di chi la narra. Resta da sperare solo che quanto meno ci siano dei ricordi sia da una parte che dall’altra, benché non possano mai essere gli stessi per entrambi. E non vale neppure la pena rammaricarsi e sospirare per i “bei tempi andati”, ma possiamo guardarli senza giudizio, solamente in quanto tasselli imprescindibili del nostro percorso di crescita e di vita.
Dunque, anche in estate, anche quando vorremmo che sia già settembre per farci imbambolare dal tran-tran quotidiano, anche quando ci assale la nostalgia delle merendine che divoravamo a iosa durante la nostra infanzia, pensiamo alla bellezza del presente, malgrado lo sfacelo della situazione globale. Pensiamo a goderci questa noia come una fugace tregua. Pensiamo alla bontà degli snack industriali. Perché, tanto, “non torneranno più le merendine di quando ero bambino, i pomeriggi di maggio non torneranno più”, “i pomeriggi di maggio, le merendine con pane e cioccolata…”, “il brodo di pollo quand'ero malato... gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze…” non torneranno più…
Autore
Niccolò Delsoldato
Di questa Rubrica:



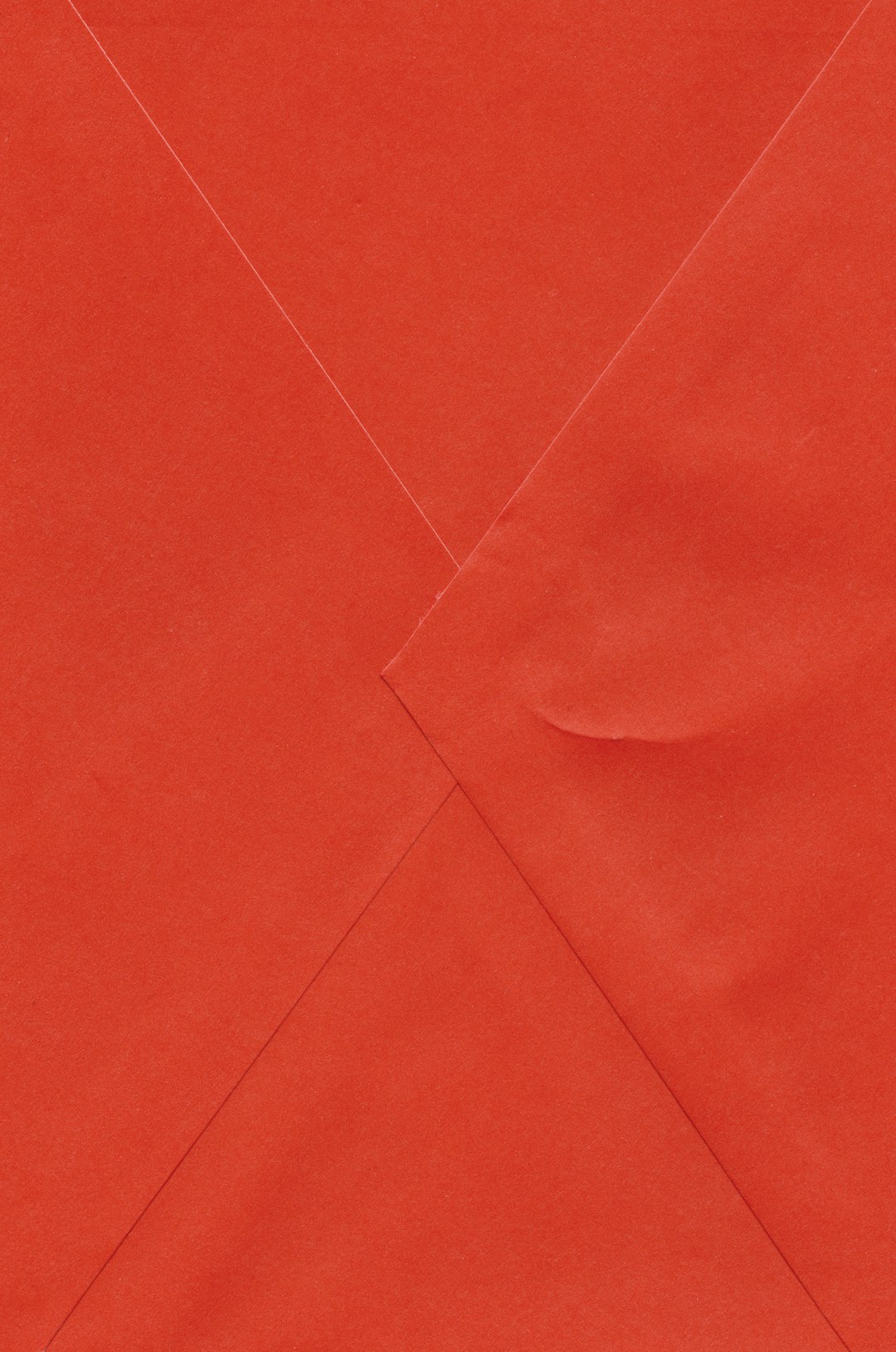


Potrebbero interessarti:











