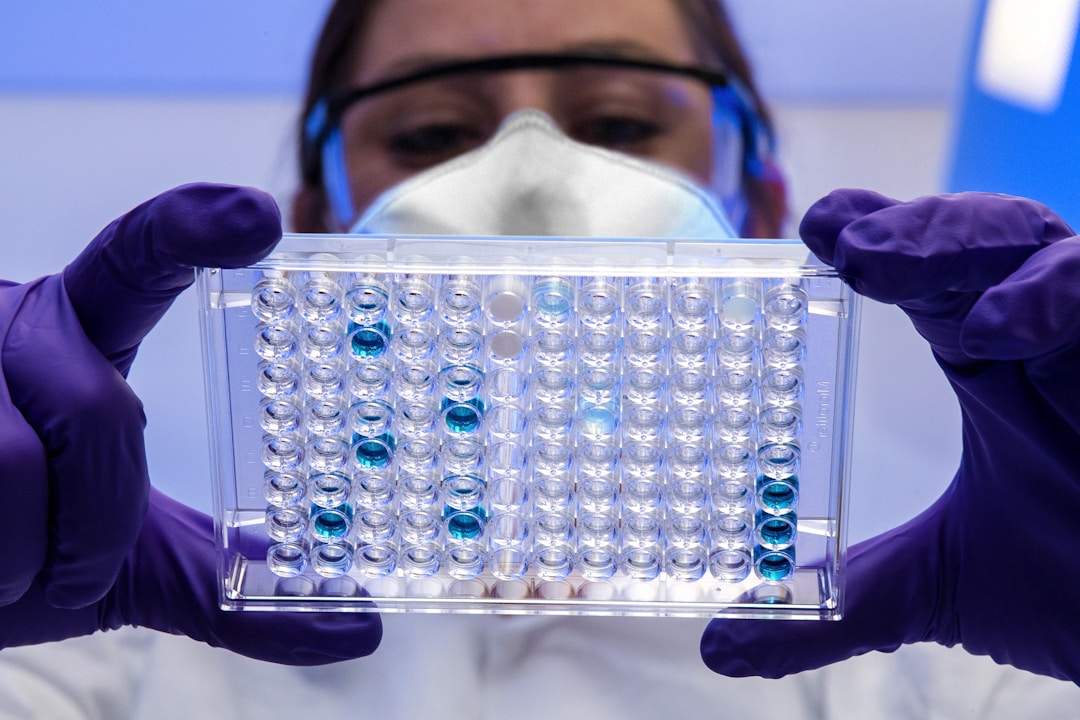3
È senz’altro innegabile che ci siano periodi, nella nostra vita, in cui l’universo sembra avere una gran voglia di strozzarci. È sadico, quel bastardo che chiamiamo Cosmo. Non ne capita una giusta, tutto ci va male, ci sentiamo insensibili a qualsiasi evento. Eppure, malgrado la disperazione, malgrado tutto ci porti, nei momenti più neri, a fantasticare di non essere mai nati, non ci spezziamo. Come mai?
Diceva bene Grazia Deledda, siamo canne al vento. Anzi, per usare le sue esatte parole: “Siamo come canne, è vero: ma canne che pensano.” A sorreggerci, infatti, abbiamo al nostro fianco l’Immaginazione, ovvero la capacità di desiderare e sperare un futuro diverso. E chissenefrega se quelle peregrinazioni della mente paiono fini a sé stesse, se intavolano scenari impossibili da realizzare o se sembrano distrarci dai problemi concreti, alla cui soluzione dovremmo invece impegnarci con pragmaticità. Sia che il mondo ci faccia schifo, sia che ci piaccia pur in ogni sua ombra, è fondamentale poter ripensarlo a modo nostro, reinterpretarlo anche a costo di seguire una speranza allòcca e quasi idiota. Quell’antico bisogno di plasmare mondi inattuabili, sebbene sia stato praticato sin da Platone quando auspicava una Repubblica governata da filosofi, è stato più sistematicamente concettualizzato dal pensiero occidentale più recente: solo Tommaso Moro, nel 1516- mentre usciva quel crogiuolo inesauribile di mondi e storie che è l’Orlando Furioso, e mentre si preparavano le tesi di Lutero, destinate ad inaugurare una nuova epoca l’anno seguente- fu in grado di dargli un nome, “Utopia”. Il pensatore inglese concepì la filosofia del “non-luogo” per descrivere un'isola immaginaria, patria di una società ideale perfettamente organizzata secondo principi di giustizia, uguaglianza e razionalità — in contrasto con le ingiustizie dell'Europa del suo tempo. L’immaginazione lo ha fatto approdare verso le sponde ottimiste di quell’isola, battezzata proprio “Utopia”, che altro non è se non la rivisitazione di quella speranza che l’umanità già riponeva nel Paradiso Terrestre prima della cacciata di Adamo. Sulle stesse rosee prospettive si erano mosse le leggende medievali sul regno del Prete Gianni. Le stesse orme seguirono poi Tommaso Campanella, Francis Bacon, le utopie socialiste di Arthur Bellamy, quelle anarchiche di Fourier, eccetera. Finché, nel Novecento, le Guerre condussero ad uno shock talmente violento da squartare ogni fiducia in un futuro di giustizia e prosperità. Fu così che il concetto utopico divenne distopico, che la speranza cedette il passo alla paura, che la Terra di Cuccagna divenne Terra di Miseria. Huxley e Orwell ci hanno insegnato quanto sia fragile il confine tra Utopia e Distopia, sempre, tuttavia, esprimendo quel bisogno di mettere in discussione il mondo reale. Se prima la fantasia serviva a lenire la nostra rassegnazione verso una materialità insoddisfacente, la distruzione della guerra ci ha poi rivelato che la capacità immaginifica vuole metterci in guardia dal baratro in cui l’umanità rischia sempre più di scivolare.
Pertanto, chiunque manchi di fantasie utopiche non fa che rigettare le sue frustrazioni cercando di disfare il mondo in cui vive e di cui è inconsciamente deluso. Con “chiunque” vogliamo intendere una certa categoria di subumani come Netanyahu, Trump, Putin, e tutta la marmaglia che ne segue.
Il bisogno di utopizzare non può però distrarci dalle contingenze del presente. Spesso, infatti, tendiamo a dimenticare che ciò che sta accadendo a Gaza- per usare un esempio tra i tantissimi abominevoli conflitti in corso- non è un evento estraneo a noi, non sta succedendo in un “non-luogo”. A soffrire e a subire un genocidio – non dobbiamo aver timore di chiamare le cose con il loro nome- è un popolo reale, che non merita la nostra indifferenza. Occorre mantenere sempre vivo il contatto con le contingenze del nostro tempo, occorre rimanere nel “qui ed ora” senza annullare in un sogno utopico la realtà- soprattutto quando siamo in vacanza, e cioè quando tutto ciò che sta oltre il nostro ombrellone sbiadisce e diventa diafano.
Proprio con l’obiettivo di consolidare l’appiglio col mondo circostante, ci siamo cimentati, più che in qualsiasi altro mensile, in numerose interviste e riflessioni sulle problematiche della nostra generazione.
A tal proposito, le generazioni più giovani vengono accusate di essere bruciate da un uso sconsiderato dei social e della tecnologia. L’emblema di questo “decadimento generazionale” è generalmente riconosciuto nei memes idioti che girano sul web, ultimamente esemplificato nei cosiddetti “brainrot”. Malgrado il nome con cui questi memes sono conosciuti alluda ad una sorta di decomposizione cerebrale, denotando già un giudizio negativo, non possiamo negare che essi rappresentino una forma di utopia ipermoderna, creata con lo scopo di divertirci e di farci evadere ironizzando vari aspetti del mondo fattuale. Lungi da noi muovere un’apologia ai brainrot, ci preme tuttavia sottolineare che non bisogna demonizzare a priori tutto ciò che è nuovo e connesso alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale: esse sono lo specchio della società, nonché il riflesso dei nostri bisogni di utopia, che evolvono da epoca a epoca e da generazione a generazione. Questa continua evoluzione del modo di concepire l’utopia, destinata ogni volta ad essere esecrata dalla generazione precedente, non rappresenta un decadimento morale e intellettivo, non è una disgregazione dei valori, ma un semplice mutamento del rapporto tra realtà e immaginazione, tra mondo e utopia.
Per fare un esempio, non troppo tempo fa, quando cominciarono a comparire i primi fantasy moderni, gli autori dediti a tali mondi immaginifici furono relegati ad un genere di bassa lega, ad una sorta di paraletteratura. Eppure, Tolkien, G. R.R. Martin, Leigh Bardugo, Rebecca Yarros- e si potrebbe continuare l’elenco per pagine intere-, sono ora guardati con profondo rispetto, proprio in virtù della popolarità che hanno acquisito. I mondi e i personaggi che hanno plasmato sono diventati il ritratto in cui la contemporaneità voleva essere incorniciata. Ogni nuova utopia ha pertanto la stessa dignità della precedente, in ragione del fatto che solo la vis imaginis, qualunque forma assuma, fornisce gli strumenti in vista del progresso- che sia esso tecnologico, sociale, morale o economico.
È solo partendo dall’impossibile che si può giungere ad uno sviluppo umano possibile.
Che cos’è l’umanità senza utopia?
Avremmo forse mosso il nostro primo passo sulla luna, se prima non avessimo immaginato Astolfo intento a recuperare lassù la ragione di Orlando? Avremmo mai ambito a un’impresa tanto grande, se Cyrano de Bergerac non avesse destato la curiosità, descrivendo il nostro satellite come un luogo ricco di meraviglie, popolato da strani abitanti e dominato da leggi fisiche stravaganti?
E dunque rimaniamo legati al presente, pur mantenendoci in movimento verso un Utopia pronta a divenire eutopia!
Autore
Di questa Rubrica:



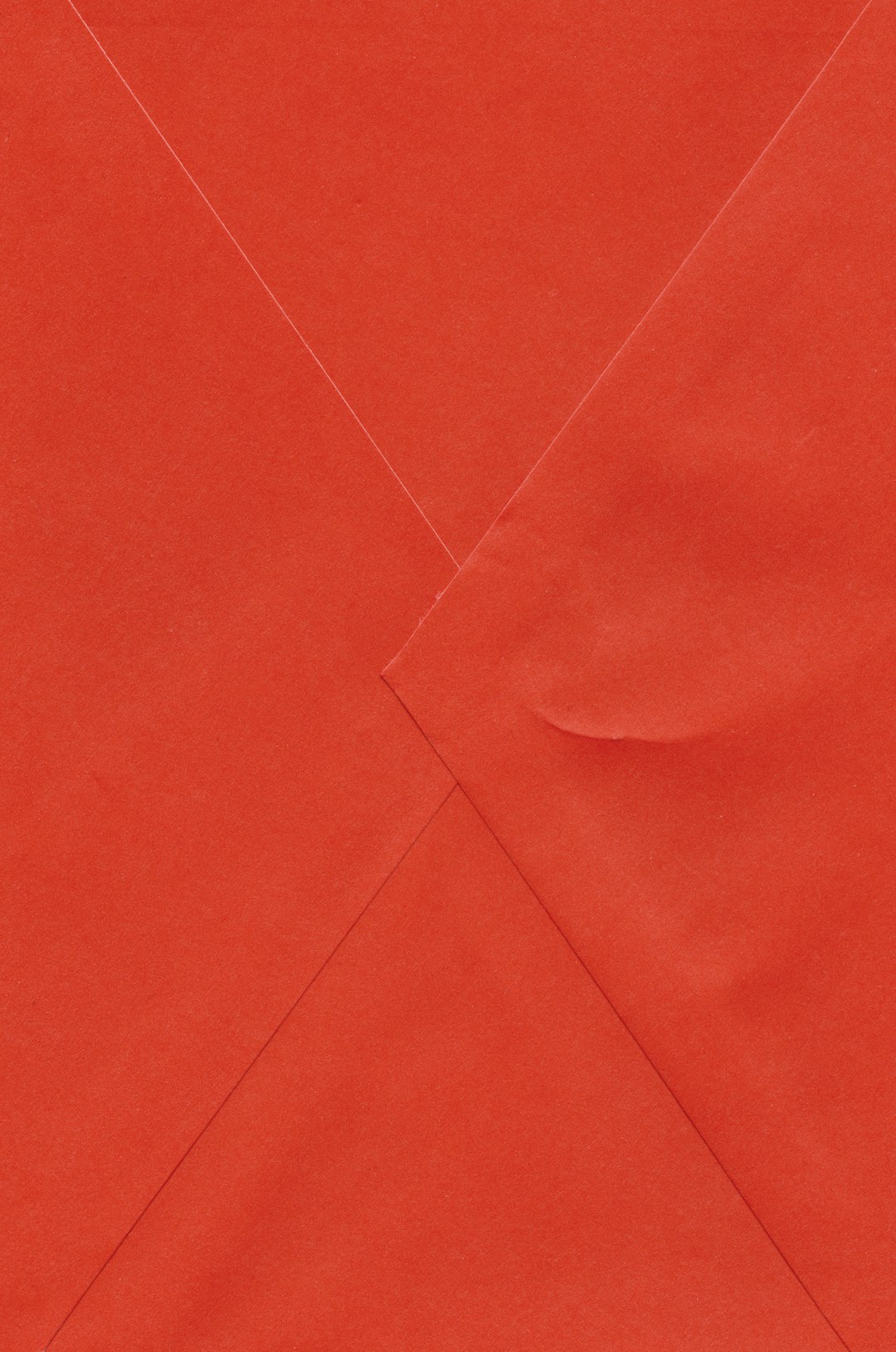


Potrebbero interessarti: