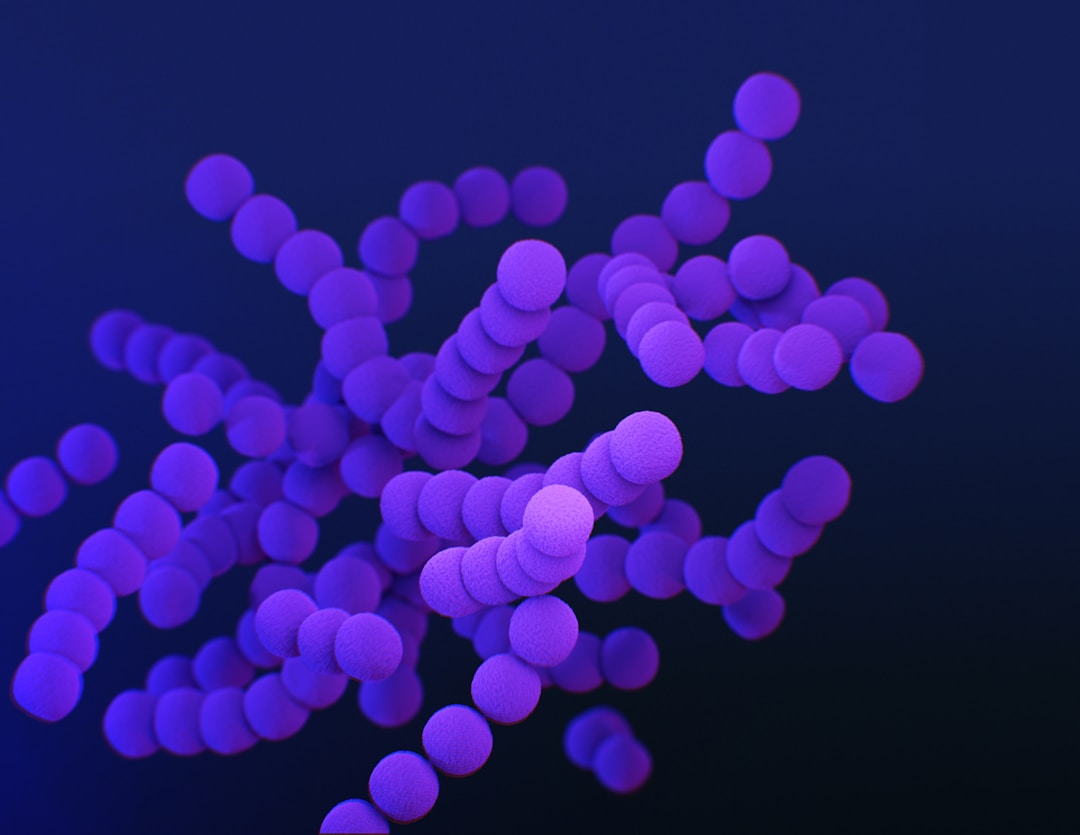3
Perché la politica non decide più niente
La democrazia sotto anestesia
L'8 e il 9 giugno milioni di italiani sono stati chiamati a votare e milioni hanno risposto: no, grazie. Chi per indifferenza, chi per disillusione, chi per rabbia, chi per ideologia, insomma il problema non è che la gente è pigra, ma ha capito che le decisioni importanti non passano più per il Parlamento, i programmi elettorali si sciolgono il giorno dopo il voto, le promesse si fanno in campagna, i tagli si fanno a Bruxelles; e che il voto, nella migliore delle ipotesi, sposta le poltrone, non le regole. Ma c’è anche chi, come me, c’è andato, ma ha votato scheda bianca. Non per apatia o indifferenza per i quesiti o per sostenere l’astensionismo partitico. Per protesta. Per chi non ci sta. Non credo più a questa politica che non fa politica. Non credo a una democrazia che mi chiede fiducia ma la tradisce ogni giorno. Perché se la partecipazione al voto è diventato un rito svuotato, allora l’unico voto libero è quello che rifiuta di esserne complice, non con l’astensionismo, ma con la protesta della scheda bianca. Non è un “non mi interessa”. È un “così com’è, questo non mi rappresenta”. E finché non si avrà il coraggio di dirlo, il distacco tra popolo e istituzioni continuerà a crescere.
La grande illusione: la politica come teatro
Sono uno strenuo difensore del diritto di voto, il voto ci rende liberi, ci ha permesso di essere liberi oggi, ci ha costruito come cittadini; quindi, non è solo un diritto ma un dovere di ciascuno, ma proprio oggi la retorica del “dovere civico” è spesso usata come arma ideologica: ti dicono che votare è sacro, ma solo se voti “bene” (cioè secondo i loro interessi). La propaganda partitica infatti non informa, addestra, non è al servizio dei cittadini, ma al servizio dei partiti stessi. Ti fanno votare, ma solo se sei d’accordo con loro. Altrimenti silenzio. Non ti aiuta a capire, ti spinge a schierarti. È una retorica che trasforma il cittadino in tifoso e il dissenso in eresia. Ecco perché la gente non partecipa: perché ha già partecipato e ha visto com’è andata a finire. Ha perso fiducia.La politica è diventata uno spettacolo: un talk show travestito da istituzione. I veri poteri agiscono dietro il sipario, dove i cittadini non entrano mai. I politici litigano sul palcoscenico, ma si inchinano agli stessi vincoli: quelli economici, quelli contabili, quelli che nessuno ha mai votato.
L’era della tecnocrazia
Come la politica non fa più politica, anche il politico non fa più il politico; sono tecnici travestiti da leader. E lo si vede. Soprattutto in Italia. Persone come Draghi, Monti, Conte e altri non sono stati rappresentanti del popolo, ma manager chiamati a gestire una macchina economica e finanziaria fuori dal controllo democratico. Il vero potere non abita più nei palazzi del governo, ma nei centri finanziari e nelle stanze di questa tecnocrazia. Chi decide davvero non è chi viene eletto, ma chi controlla il flusso del denaro, il credito e le valutazioni di rating. I politici eseguono, comprimono diritti e servizi per rispettare regole imposte da altri, lontani e invisibili. Così la politica diventa un’arte del compromesso ridotta a mera amministrazione, svuotata di visione e ambizione. Non siamo più in una democrazia. Siamo in una oligarchia economica mascherata, dove il cittadino è spettatore e il capitale è sovrano. Votiamo ogni cinque anni, ma il mercato vota ogni secondo. E il suo voto vale di più.
L'astensionismo come sintomo
Oltre all’ideologia e all’astensionismo partitico che colpisce i referendum (per questo è più suscettibile al fallimento, infatti non votare è funzionale a non far raggiungere il quorum, ovvero il 50%+1: è una strategia politica, sabotano il dibattito promuovendo l’astensionismo), l’astensionismo è un sintomo grave che rappresenta non più un’emergenza momentanea, ma un crollo strutturale della fiducia democratica. Da più di trenta anni a questa parte vi è stato una caduta sistemica della partecipazione al voto: alle elezioni europee del 2024, in Italia ha votato il 49,69% degli aventi diritto: più della metà del Paese ha scelto di non scegliere. Nel 1989 (a 35 anni di distanza) alle europee, l’affluenza era 81,07%, -31,38%, in modo graduale. Ma il fenomeno non è isolato. Alle elezioni politiche del 2022, l’affluenza è crollata al 63,9%, il minimo storico nella storia repubblicana. Nel 1987 (quasi 40 anni fa) era dell’88,86%, -24,96%, anche qui in maniera graduale. Tuttavia, la responsabilità è doppia: un sistema che si è distaccato dai cittadini e i cittadini che hanno rinunciato a pretendere visibilità. Perché se milioni di persone si astengono per disillusione, sfiducia o senso di impotenza, è anche vero che rinunciare alla partecipazione in un sistema che già la svuota significa lasciare spazio al peggio. Non tutto si può ridurre a “non mi interessa”. Anche il vuoto ha un prezzo. Anche il silenzio è una scelta politica. Il sistema si è svuotato, sì. Ma anche il cittadino ha disertato il campo. L’astensionismo oggi è una malattia a doppio volto: da una parte una politica che non ascolta, dall’altra una cittadinanza che ha smesso di parlare. E se la politica è morta, allora dobbiamo chiederci: chi l’ha uccisa? E chi l’ha lasciata morire?
La politica è morta. La politica resta morta. E noi l’abbiamo uccisa.
La politica non è morta da sola. L’abbiamo uccisa noi, collettivamente. L’ha uccisa chi l’ha trasformata in una contabilità, chi ha sostituito la visione con l’algoritmo, la scelta con la gestione, il confronto con il pareggio di bilancio. L’ha uccisa chi ha consegnato la sovranità democratica ai mercati, chi ha firmato trattati vincolanti senza alcuna discussione pubblica, chi ha accettato la subalternità del diritto alla logica del profitto.Ma l’ha anche lasciata morire chi avrebbe potuto difenderla. Chi ha smesso di partecipare. Chi ha votato sempre il “meno peggio”. Chi ha rinunciato all’indignazione, convinto che nulla cambi, e così ha permesso che nulla cambiasse. Chi si è adattato, rassegnato, silenziato. Chi ha accettato che tutto fosse inevitabile. Ma niente è inevitabile. La realtà non è una pioggia che ci bagna, è una strada che scegliamo (o lasciamo scegliere ad altri).Non si tratta di colpe individuali, ma di responsabilità collettive. La rinuncia sistematica alla partecipazione è anche una complicità passiva.
La verità è che la politica ha smesso di essere il luogo del possibile. E noi abbiamo smesso di crederci. Ora non si tratta solo di criticare il sistema. Ma di ritornare a immaginare un’alternativa, non restituire la vita alla vecchia politica, ma reinventarla. Perché se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro. E non sarà per forza meglio, anzi.
La vera rivoluzione è quella economica
Se la politica è morta, non è solo perché l’abbiamo tradita, ma perché ha perso il potere reale: quello economico. Come scriveva Marx, “l’economia è la struttura della società, il resto (le leggi, la politica, la cultura) è sovrastruttura”. La rivoluzione, allora, non può che partire dalla radice, dal cuore pulsante di ogni sistema: l’economia. E questo lo puoi fare solo con la politica. La politica deve riconquistare il potere di trasformare la struttura, e non limitarsi a decorarne la facciata. Oggi, invece, la politica è stata inglobata dalla logica del mercato: non guida l’economia, la subisce. Non la indirizza, la gestisce. E in questo passaggio, da potere a procedura, è morta. Quando la politica non riesce più a dirigere l’economia, si crea un vuoto che viene riempito da un capitalismo senza freni o, peggio, da un capitalismo di Stato, in cui il potere si concentra nelle mani di pochi tecnocrati travestiti da salvatori. È la fusione tossica tra neoliberismo e controllo statale: lo Stato non garantisce più i diritti, ma gestisce l’austerità. Non guida il mercato, ma lo legittima. Eppure, la storia insegna che ogni rivoluzione autentica è passata da un ripensamento dei rapporti economici. Lo diceva anche Gramsci: “la crisi consiste nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere”. Siamo in quel momento esatto. E il nuovo nascerà solo se torneremo a immaginare un’economia giusta, redistributiva, ecologica, capace di mettere l’essere umano al centro, non il profitto. La rivoluzione che serve non è solo politica: è economica, culturale, antropologica. Una rivoluzione che parte dalle relazioni di produzione, ma che deve coinvolgere anche la scuola, l’informazione, la coscienza collettiva. Perché cambiare il mondo non è solo questione di chi, ma di come e perché lo fa.
Autore
Alessandro Michi
Potrebbero interessarti:





Dello stesso autore: