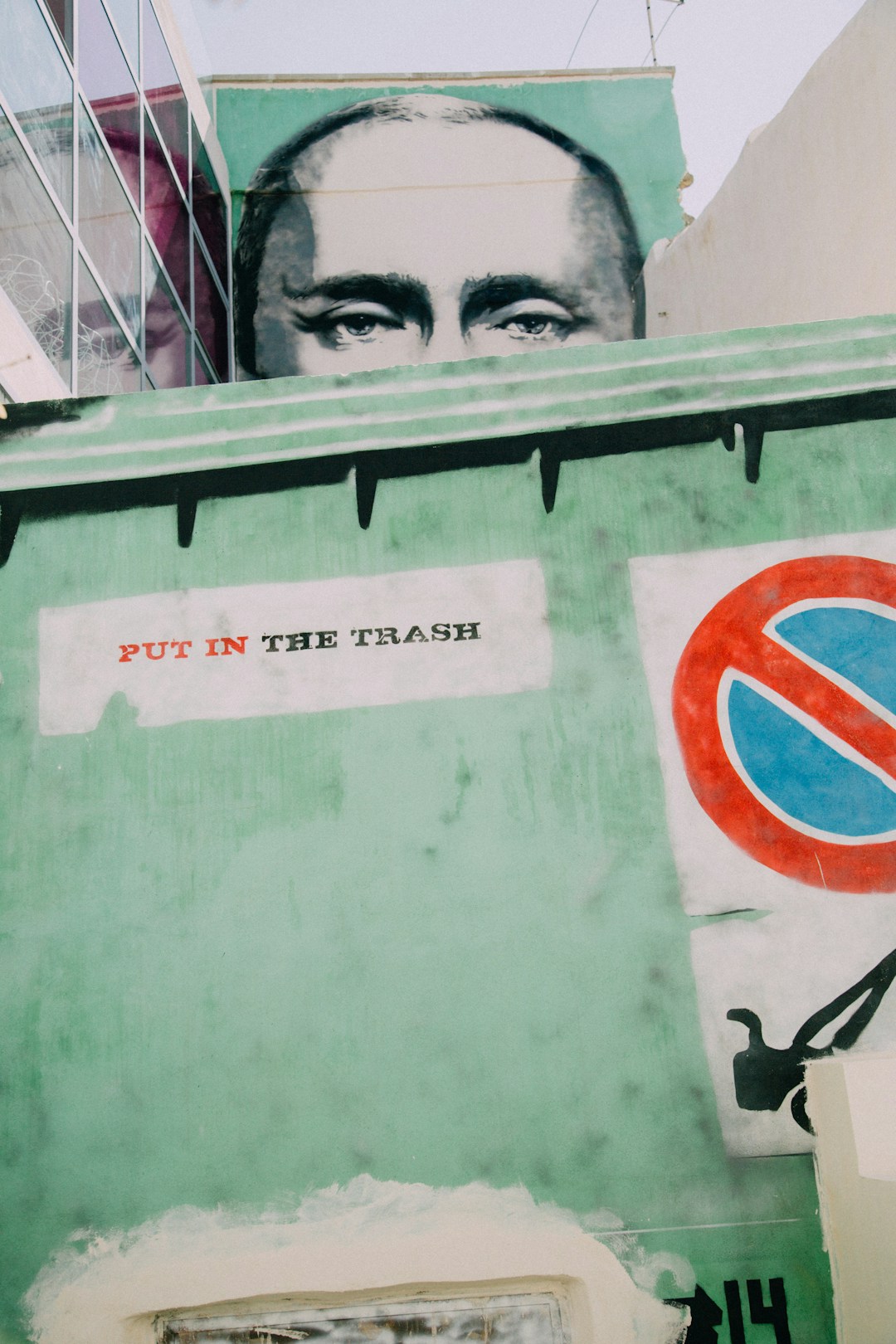3
"Ancora? Ma io ho già firmato". Questa la frase che qualunque attivista della Luca Coscioni si sta sentendo ripetere spesso negli ultimi giorni. "Si, ancora. Ci si riprova, di nuovo." è di solito la risposta.
Dal 26 giugno, è partita in tutta Italia l'ennesima mobilitazione sul fine vita. L’obiettivo è raccogliere 50 000 firma in appena 2 settimane per depositare in Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia, per chiedere il riconoscimento di ciò che per molti è un concetto chiaro: anche morire, quando tutto diventa dolore, può essere un atto di libertà e di amore. Ma perché ora? Perché ancora? Perché dopo decenni di sfiancanti dibattiti, casi mediatici, disobbedienze civili, processi e sentenze, l’Italia non ha ancora una legge completa, chiara e soprattutto rispettosa del diritto di autodeterminazione individuale. Si sa, il nostro Paese è una terra di antiche e radicate tradizioni religiose e giuridiche. Antiche e radicate almeno quanto inamovibili. Qui, la consapevolezza sul diritto a decidere della propria morte si è fatta strada molto lentamente, attraverso casi giudiziari simbolici, pressioni culturali e infinite riflessioni etiche e morali. È uno di quei crocevia in cui bioetica, giurisprudenza, politica e spiritualità si incontrano e si confrontano sul confine più delicato di tutti, cioè il momento in cui il diritto incontra la carne viva dell'esistenza. Il dibattito, a lungo accantonato e rimandato, si è imposto a colpi di storie umane, di battaglie e azioni legali, che hanno progressivamente scardinato l'inerzia legislativa. Oggi, nel 2025, ci troviamo in una "terra di mezzo”: tanto è stato fatto, eppure molto di più resta ancora da scrivere.
L'Italia è arrivata tardi e con molta fatica a riconoscere, solo parzialmente, il diritto all'autodeterminazione in ambito medico. Fino agli anni 2000 nessuna legge prevedeva alcuna forma di scelta del paziente. A dire il vero, la Costituzione già dal 1946 riconosceva, con l'art. 32, che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Ma un relitto del passato fascista come il Codice penale Rocco, ancora in vigore, considera l'eutanasia come "reato di omicidio del consenziente". Solo a partire dagli anni '90 qualcosa comincia, molto gradualmente, a cambiare. Ma sono servite delle drammatiche vicende umane per scuotere definitivamente le coscienze sulla morte dignitosa. "Morire dignitosamente". Ecco, forse questa definizione non è giusta.
"Morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita. È' solo un testardo e insensato accanimento nel mantenere attive delle funzioni biologiche. ...
La morte non può essere “dignitosa”; dignitosa, ovvero decorosa, dovrebbe essere la vita, in special modo quando si va affievolendo a causa della vecchiaia o delle malattie incurabili e inguaribili." P.W.
Radicale, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, Piergiorgio Welby, dopo anni di battaglie, nel 2006 scrisse al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, chiedendo di poter porre fine ad una vita che le macchine mantenevano artificialmente attiva, ma che per lui aveva perso di ogni significato. Era affetto da distrofia muscolare e la sua morte volontaria, accompagnata dal medico Mario Riccio, fu allo stesso tempo un gesto di liberazione e di denuncia. Ma Welby non era solo. Alcuni anni prima, nel 2002, Luca Coscioni, economista e attivista radicale, affetto da sclerosi laterale amiotrofica che lo condurrà alla morte a soli 38 anni, aveva fondato l'associazione che porta il suo nome. Questa sarà diventerà negli anni successivi, e fino ad oggi, la principale promotrice di dibattiti, campagne, azioni legali, referendum e proposte di legge per la promozione e difesa della libertà di cura e di ricerca scientifica.
Poco dopo, fu la volta di Eluana Englaro. Dopo un incidente stradale, Eluana rimase in stato vegetativo per ben diciassette anni e suo padre, Beppino, lottò per il riconoscimento del diritto della figlia a non essere mantenuta in vita artificialmente contro la sua volontà. Volontà espressa prima dell’incidente. La lunga battaglia mediatica e legale, sostenuta in buona solitudine sempre dai soliti radicali, si concluse con una sentenza della Corte di Cassazione che autorizza la sospensione dell’alimentazione forzata. Ma fu una vittoria amara, visto il clima tristemente conflittuale in cui avviene, oltre che parziale. Una svolta giunse soltanto nel 2017. Fu durante il governo Renzi (si, ha fatto anche cose buone) che venne riconosciuto formalmente il diritto ad esprimere il proprio consenso rispetto ai trattamenti sanitari attraverso le cosiddette DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento. Un passo importante ma circoscritto. Se da un lato la legge garantisce il diritto di rifiutare l’accanimento terapeutico, dall’altro suicidio medicalmente assistito e l’eutanasia restano esclusi. Il vuoto lasciato dal Parlamento è stato così riempito, almeno in parte, dalla magistratura e solo grazie ad alcune storiche sentenze è nata una forma embrionale di diritto al fine vita.
“Andrò via col sorriso perché vivo nel dolore”. F.A.
Fabiano Antoniani, detto Dj Fabo, rimane cieco e tetraplegico in seguito a un incidente. La sua richiesta di aiuto per poter morire trovò un alleato nel solito radicale, l'attivista Marco Cappato insieme sempre all'A.LC. Si recarono in Svizzera, dove il suicidio assistito è praticabile in condizioni legali. In coerente applicazione del "metodo radicale" della disobbedienza civile, Cappato si autodenuncia appositamente per portare il caso di fronte alla Corte costituzionale. Con la storica sentenza 242 del 2019 venne dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 580 del Codice penale, quello che punisce l’aiuto al suicidio, nella parte in cui non prevede eccezioni per persone in precise condizioni cliniche. È un passaggio epocale. Per la prima volta, viene riconosciuta l'esistenza di un diritto a morire assistiti. Non una legalizzazione dell’eutanasia, ma un’apertura concreta verso una forma controllata di suicidio medicalmente assistito. In mancanza di una legge, è stata la giurisprudenza a fare da supplente all'inerzia della politica. In quel pronunciamento, la Corte ha tracciato i confini di una nuova libertà.
Il Parlamento, al contrario, non ha ancora trovato il coraggio per approvare una legge che disciplini organicamente il fine vita. Le proposte depositate si scontrano con veti ideologici e con una perdurante incapacità del legislatore di assumersi la responsabilità politica del tema. Qui si inserisce la grande raccolta firme del 2021 a cui tutti pensano quando approcciati dai volenterosi attivisti delle Cellule Coscioni in tutta Italia. L'A.L.C. e radicali con parenti ed affini, insieme ad un ristretto gruppo di partiti di centro-sinistra tendenzialmente piccoli, riesce a raccogliere oltre 1 milione di firme per convocare un referendum abrogativo. Ma la Corte costituzionale, presieduta da Giuliano Amato, aveva idee diverse e ne ha dichiarato l’inammissibilità con una sentenza molto dibattuta e controversa. Le nostre antiche e radicate tradizioni giuridiche in tutta la loro staticità.
Ma non si molla. Seguirà una capillare raccolta firme in tutte le regioni, non serve ripetere promossa da chi, per delle proposte di legge locali che regolamentino il suicidio assistito. Pecora nera della famiglia, Zaia ci prova in Veneto ma fallisce. Toscana ed Emilia-Romagna accolgono e approvano delle direttive regionali. Però non sono leggi ma direttive, quindi impugnabili. Esattamente come fa una consigliera regionale di Forza Italia in Emilia-Romagna; con il TAR che accoglie e blocca tutto. Oggi, il diritto alla fine vita in Italia si trova quindi in un limbo giuridico. Riconosciuto in via eccezionale, ma non regolato in modo sistemico, con una politica che attende ancora, mentre le persone, pazienti, medici, familiari, continuano a doversi muoversi tra ostacoli, silenzi e soluzioni individuali.
La questione del fine vita ci pone di fronte a una delle domande più antiche e disarmanti dell’essere umano: chi ha il diritto di decidere quando la vita ha perso la dignità di essere vissuta? In una democrazia matura, la risposta non può essere imposta dallo Stato né dalla Chiesa. E neppure essere affidata alla casualità delle aule di giustizia. Deve nascere dal riconoscimento profondo della libertà individuale, anche quando si esprime nell’ultimo gesto. La morte è l’ultima parte della vita e come tale merita rispetto, ascolto e, soprattutto, la possibilità di essere scelta, non subita. La società italiana è pronta. Ora tocca alla politica dimostrarlo. Oggi esiste una finestra aperta. Piccola, fragile, ma reale. Sta a noi decidere se trasformarla in una porta, o chiuderla nel silenzio delle leggi mai scritte.
Autore
Luca Amadasi
Potrebbero interessarti: