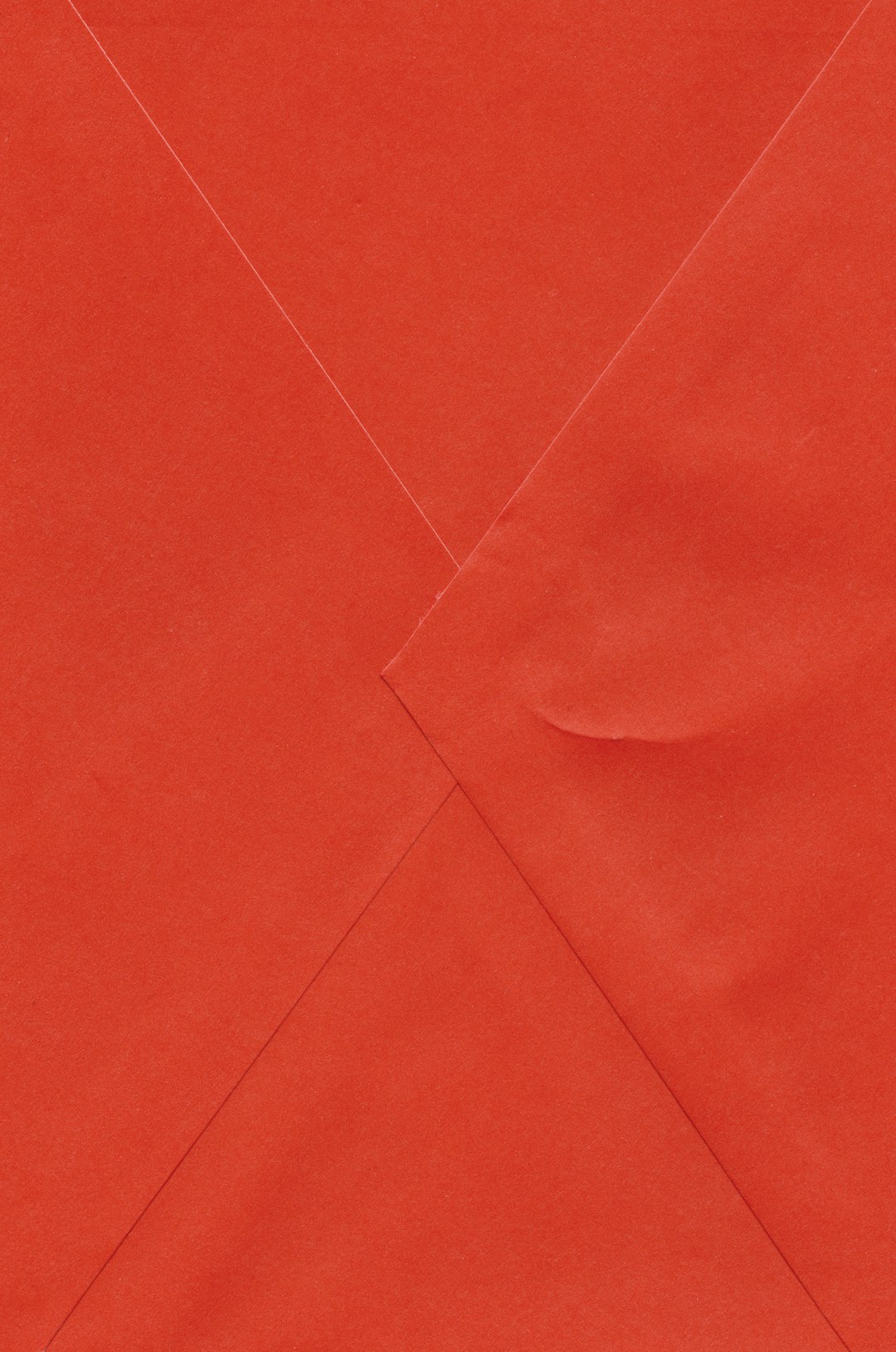4

“Non dovete far altro che continuare semplicemente a essere voi stessi: il che significa essere continuamente irriconoscibili. Dimenticare subito i grandi successi e continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari, a pretendere, a volere, identificarvi col diverso”.
Queste sono parole di Pier Paolo Pasolini, rivolte idealmente a tutti gli attori che hanno dato vita a questo magico spettacolo. Colgo l’occasione per ringraziarli uno ad uno: Monica Barone, Sally Demonte, Alfonso Donnarumma, Susanna Ferrante, Costanza Leporatti, Mattia Molini, Christian Pellino e Salvatore Sciancalepore.
Sono passati ormai cinquant’anni dalla morte di Pasolini, e Monica Casadei, regista e coreografa, che con grande gentilezza ha concesso un’intervista al nostro giornale dopo la pièce, ha proposto un nuovo allestimento del suo progetto dedicato a uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento. Nella serata del 7 ottobre, lo spettacolo è stato reso accessibile anche al pubblico ipovedente, grazie al servizio di audiodescrizione; mentre la sera successiva, 8 ottobre, è stato tradotto nella Lingua dei Segni Italiana, grazie al contributo di Cinzia Barbieri e Marika Maranesi. Tutto questo per dare vita a un’esperienza quanto più possibile inclusiva, capace di accogliere davvero ogni spettatore.
LO SPETTACOLO

Dopo le prime note musicali che annunciano l’evento, i protagonisti entrano in scena. Lottano ferocemente, ma con una levitas quasi sacrale, per assicurarsi le copie cartacee delle opere di Pasolini. Quella che sembra una rissa si trasforma presto in una coreografia acrobatica, pensata per introdurre il tema e la materia stessa dello spettacolo.
Una figura maschile misteriosa si accascia al suolo: diventa un piedistallo, il fulcro su cui si innalza una figura femminile che domina la scena, protagonista assoluta della danza.
Segue la voce profonda, ma non greve, di due donne in sedia a rotelle: recitano Il Glicine, poesia contenuta nella raccolta La religione del mio tempo (1961). Forse la più polemica e rabbiosa della raccolta, essa esprime la disillusione dell’immenso amore del poeta per la realtà, e la consapevolezza di una svolta irrimediabile nel mondo occidentale. È la crisi della civiltà popolare distrutta dal boom economico, ma anche la crisi dell’intellettuale e della funzione poetica.
Nel frattempo, due ballerini – un uomo e una donna – accendono lo sguardo del pubblico con virtuosismi sontuosi.Poi, una donna scende nell’arena: è talmente graziosa che quattro giovani la rincorrono, librandosi con voluttuosità nello spazio scenico. La lasciano sola, e il palco si svuota, tranne per un uomo che continua la sua danza acrobatica, prima di cedere il passo a un flusso di corpi che si alternano e si intrecciano in un ritmo continuo, ipnotico.
Entra un uomo visibilmente esausto. Trascina una corda a cui sono legati dei libri, forse pasoliniani, insieme a una cesta e a un paio di scarpe lise. Cinque figure lo circondano e lo tormentano con una danza vorticosa, quasi infernale. Poi l’uomo riesce a fuggire, salvo tornare in scena poco dopo, stringendo solo uno sgabello pieghevole. È il momento di Ragazzi di vita (1955), romanzo che rivela la passione dello scrittore per le periferie romane, luoghi ancora autentici, non ancora corrotti dal consumismo.
Sul palco, due uomini e due donne incarnano quella vitalità istintiva e brutale dei personaggi pasoliniani, amplificando la pateticità della scena. L’uomo misterioso torna ancora: si contorce, muovendo prima la scapola destra, poi la sinistra. Poi siede sullo sgabello, solo, immobile, mentre due ballerini lo accompagnano lentamente dietro le quinte. Cinque attori entrano in scena, con al centro una donna in sedia a rotelle: protagonista silenziosa. A turno, alzano il pugno destro, evocando il gesto iconico degli atleti americani Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Città del Messico (1968).
La gestualità continua: le mani diventano manette, in una protesta muta ma incontenibile. Poi entra un uomo vestito di rosso, che trascina una sacca, delle scarpe logore e dei libri. Gli altri lo sollevano, lo fanno rimbalzare, lo espongono al centro del palco: un corpo sacrificato, come un simbolo.Le voci narranti tornano a guidarci nella Ballata delle madri (1964, Poesie in forma di rosa).
Pasolini si fa educatore, denunciando la maternità borghese e sottomessa, e invocando una mente libera e critica. Le madri “vili”, “servili”, “feroci” diventano emblema di una società che educa alla rassegnazione. Sulla scena, i corpi si accasciano e rotolano, accompagnando l’uomo in rosso. L’uscita è lenta, scandita da tre ballerine e da una musica che amplifica la tensione tragica. Poi, due uomini afferrano per la testa due ballerine e le scaraventano a terra, in un gesto che si ripete, ossessivo. Una di loro tenta di liberarsi, ma un altro attore la blocca. La donna in sedia a rotelle compie nuovi virtuosismi, poco prima che entri una figura femminile con il volto coperto da un bavaglio bianco. Mentre in sottofondo risuona La religione del mio tempo, sul palco quattro “giocatori” della Roma si scaldano prima di una partita immaginaria: corrono, esultano, si disperano, come marionette tragiche di una passione terrena.
Entra una donna in veste candida, solitaria, che s’inchina lentamente. È il preludio a un frammento di Capriccio all’italiana (1968), e precisamente a Che cosa sono le nuvole?, episodio scritto e diretto da Pasolini, con Totò, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Laura Betti, Domenico Modugno e Carlo Pisacane. La scena è accompagnata dalla splendida voce di Modugno, che canta l’omonimo brano scritto dal poeta.
Segue Supplica a mia madre, poesia intensa in cui Pasolini confessa il legame indissolubile con la madre Susanna: un amore che diventa schiavitù, una pena che lo accompagna sin dall’infanzia. Sul palco, tre uomini a torso nudo sollevano e trasportano il protagonista in una coreografia lenta e struggente. Poi la voce romanissima di Gabriella Ferri — Fiori trasteverini, Io cerco la Titina — accompagna otto ballerini in una danza che non si arresta nemmeno quando la musica tace: resta il suono del vento, del traffico, della vita che continua.
Gli interpreti lanciano in aria i propri abiti, li riacchiappano, li trasformano in strumenti coreografici. Un uomo tenta di scavare nel pavimento, ma gli altri lo ostacolano, gettandogli addosso le vestaglie.
Nell’ultima scena, sulle note di Modugno, gli attori restano immobili in semicerchio: al centro, un uomo stringe tra le mani le stesse vestaglie, che lentamente scivolano al suolo. Gli altri gliele sfilano, se ne appropriano, quasi a voler condividere quel peso, quella memoria. Lo spettacolo si chiude — inutilmente dirlo — tra applausi lunghi, fragorosi, increduli. Un pubblico commosso, incapace di parlare, perché forse, ancora una volta, Pasolini ha già detto tutto.

Autore
Riccardo Maradini
Samuele Castronovo
Potrebbero interessarti:






Dello stesso autore: