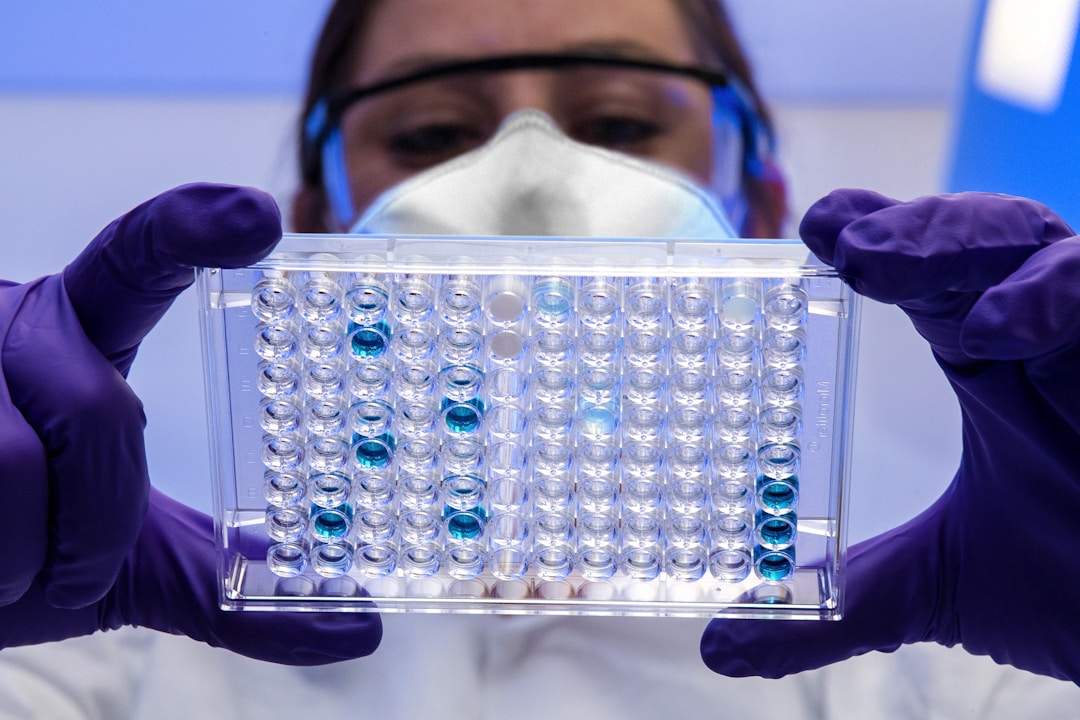2
Se la medicina esiste è perché esiste la morte, il medico nasce come risposta alla fragilità del corpo, come tentativo di arginare l‘inevitabile, di rimandare ciò che non si può rimandare. Senza la morte, quindi, non ci sarebbe bisogno di chi cura, perché nullae nessuno avrebbe bisogno di essere salvato ed è proprio in quest’ottica che la storia della medicina riflette sostanzialmente la storia della nostra ossessione a rimandare sempre più in là la morte. Questo è ben visibile nella cultura occidentale, l’ineluttabilità della morte è sempre stata presente e ciò nasce molto probabilmente da una visione lineare ed egoistica del tempo. Il punto è che il sistema non è perfetto. Con il tempo, il corpo accumula danni, errori di copia, mutazioni. I telomeri si accorciano come micce consumate, i radicali liberi erodono le strutture, il DNA porta addosso cicatrici invisibili:insomma, da quando si nasce si innesca anche il conto alla rovescia biologico. Di fronte a questo, l’uomo ha sempre cercato di barare. Gli antichi cercavano l’elisir di lunga vita, oggi inseguiamo il sogno biotecnologico: editing genetico, cellule staminali, criogenia. Ma non abbiamo il tasto reset: possiamo solo prolungare la partita, non sospenderla.Il paradosso però è che la morte non è l’opposto della vita come si è soliti pensare, ma un processo inevitabile della vita. Il nostro corpo per restare vivo ha bisogno di morire un po' ogni giorno: le cellule si suicidano (apoptosi) con una precisone matematica cheè programmata e necessaria in modo tale che i tessuti si rinnovino e le malattie non proliferino. Ma allora cos’è la morte? Un’altra definizione, forse la più famosa, è “la cessazione irreversibile di tutte le funzioni biologiche che sostengono un organismo vivente”, quindi la fine della vita; quindi, con la morte termina l’esistenza di un sistema funzionalmente organizzato. Ma qui ci ritroviamo in una definizione che ancora si aggrappa al concetto di vita, capovolgendone il significato. Ma se proviamo a definire cos’è la vita in relazione alla morte, come disse Bichat: “la vita è l’insieme delle funzioni che resistono alla morte”, allora qui la morte non viene più considerata la negazione della vita come in una sorta di dualità metafisica, ma come un processo intrinseco alla vita, una premessa indispensabile. Viviamo perché moriamo un po’ ogni giorno, e moriamo perché abbiamo vissuto. Possiamo fingere di ignorarla, anestetizzarci con distrazioni, ma non possiamo abolirla. Ed è proprio questo che ci dà un’etica. Se fossimo immortali, non avremmo bisogno di responsabilità, non ci sarebbe urgenza di scegliere, nessun peso alle azioni, nessun senso del limite. L’immortalità, in fondo, coincide con l’immoralità: senza la fine, non c’è valore, solo un eterno rinvio. È la scadenza che dà sapore, la fragilità che fonda la morale. Lo si vede anche nella biologia: il tumore è immortale, e proprio per questo immorale. Una cellula tumorale ignora i limiti, si rifiuta di morire quando dovrebbe, continua a replicarsi senza rispetto per l’organismo che la ospita. La sua “immortalità” coincide con la distruzione del corpo intero. È l’esempio più radicale di come la morte, in realtà, sia la condizione indispensabile della vita. E allora forse il compito non è illudersi di vincere, ma essere consapevoli del senso che hanno in un quadro più grande. La morte non è il grande nemico: è l’orizzonte che dà forma a ciò che siamo.
Autore
Alessandro Michi
Di questa Rubrica:

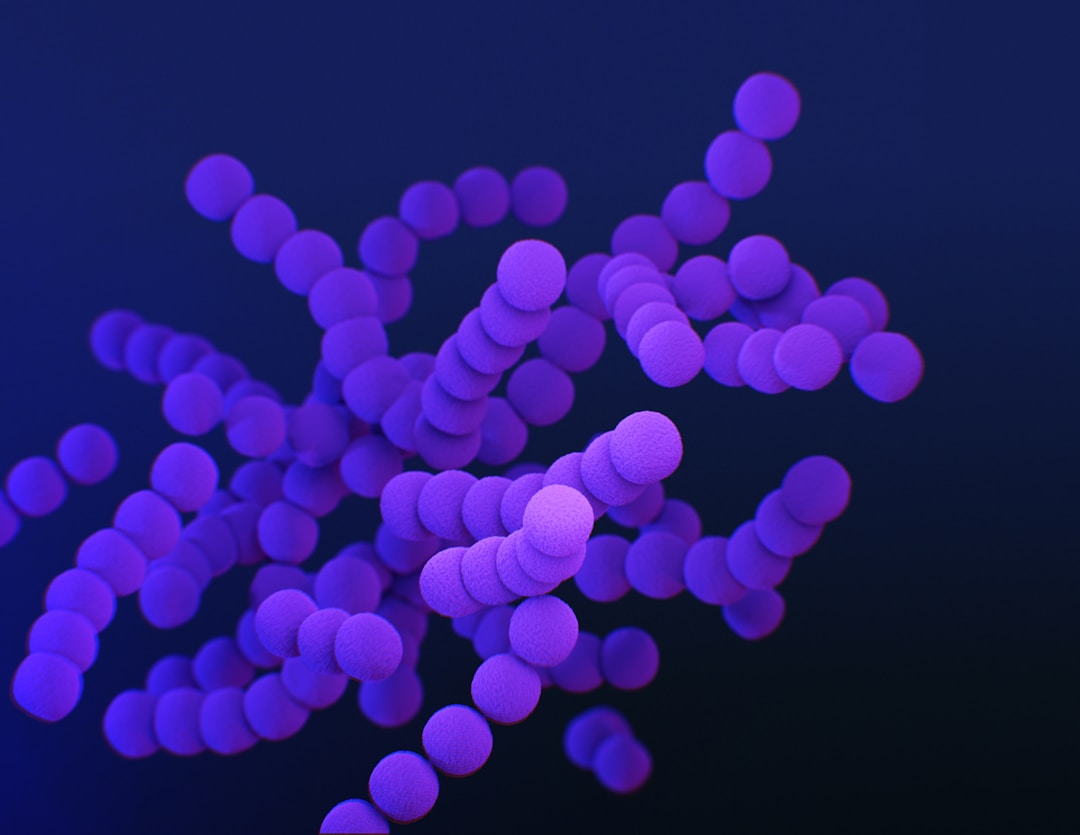

Potrebbero interessarti: