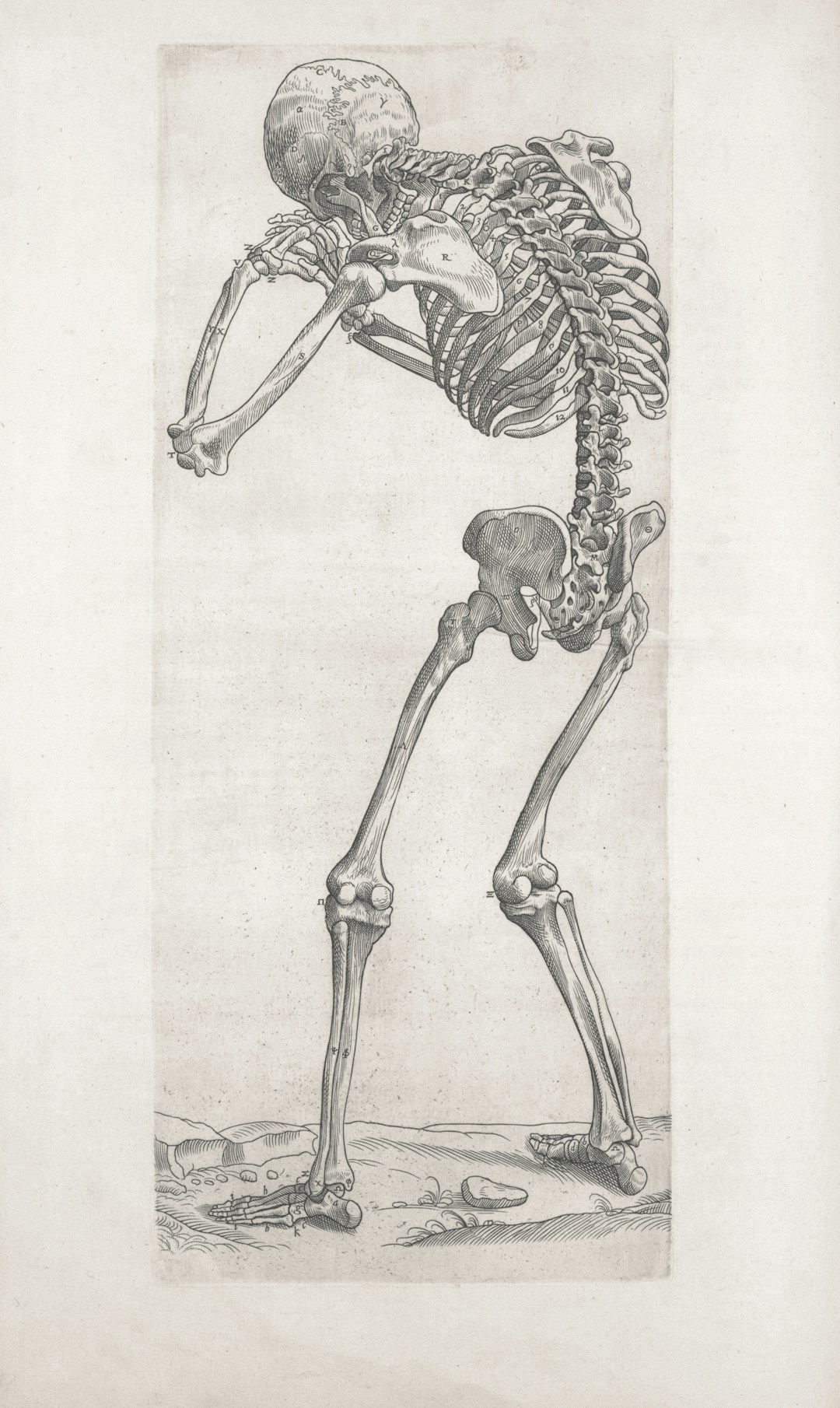5
Non c’è nulla di più spaventoso e, ad un tempo, affascinante della morte. E nulla di più versatile: se ne può parlare con angoscia, con rassegnazione, addirittura con felicità; si presta a qualsiasi tipo di trattazione, che sia scientifica o letteraria.
Al di là di tutti i diversi accenti con cui si può parlare della “secca”, intendo qui adottare un tono assolutamente personale e un punto di vista “quotidiano” - sia nel senso di contatto giornaliero con la morte, sia intendendo “quotidiano” come “giornale”.
Fin da che ho memoria, c’è un’abitudine che non mi ha mai abbandonato, né ha smesso di trasmettermi quella rassicurazione che si accompagna a tutto ciò che ci risulta familiare e immediatamente riconoscibile: si tratta della lettura dei necrologi.
Senza esagerare, potrei dire che quest’attività rappresenta una sorta di rito condiviso da tutta la mia famiglia, un’usanza cui sono stato educato fin dall’infanzia. Non l’ho mai percepito come un qualcosa di macabro, ma come una sorta di automatismo- un po’ come il levarsi dal letto e accendere la macchinetta del caffè, con gli occhi ancora cisposi e chiusi dal sonno. Non datemi del pazzo: proverò a spiegarvi come questo interesse per i morti non sia così inusuale. Se, infatti, di buon’ora provate a metter piede in qualsiasi bar della vostra città, probabilmente noterete qualche anziano, non importa se seduto ad un tavolo o appoggiato al bancone, ma in ogni caso chino su un giornale; ebbene, se siete così fortunati da coglierla nel momento giusto, dopo esservi avvicinati, vi accorgerete che sta iniziando la lettura dall’ultima pagina, per poi voltare le altre in senso contrario. Ovviamente non sta sfogliando un manga e nemmeno un testo arabo, ma, semplicemente, ha risposto a quel bisogno mattutino di fare colazione assieme ai morti, partendo cioè dagli annunci funerari, spesso destinati alle pagine finali dei quotidiani locali.
Ripensando alle giornate della mia infanzia, rivedo mia nonna venirmi incontro con un sorriso più luminoso dei raggi del mattino e una tazza di latte; dopodiché la vedo accomodarsi al tavolo della cucina, mentre l’indice della mano sinistra scorre sui minuti caratteri dei necrologi e la destra avvicina una lente d’ingrandimento a quelle indecifrabili righe nere. Allora, mi faccio appresso a lei, sporgo la testa oltre le sue spalle e mi limito ad ammirare quelle foto tanto belle quanto varie: volti per lo più solcati da rughe, che non sanno né d’addio né di dolore, ma che suggeriscono pace e compostezza al contempo. Sarà perché a quella vista ho sempre associato il profumo dei biscotti inzuppati nel latte, sarà perché tanto care mi erano le mani di mia nonna (che ha ballato un tango con la morte sotto forma di tumore per circa vent’anni, prima di abbandonarsi all’ultimo casquè) sta di fatto che un primo sincero momento di serenità quotidiana mi veniva dato dalla vista di tutti quei ritratti e dalla lettura dell’età di ciascuno al momento della dipartita. Non nascondo neppure il divertimento, del tutto innocente come può esserlo qualsiasi gioco infantile, che provavo nel creare una sorta di “classifica dei morti”, ordinandoli dal più longevo al più giovane.
Neanche il tempo che la nonna alzasse le sue rade ciglia dalla lettura, che mi fiondavo a domandarle se avesse riconosciuto qualcuno tra quei quadretti in bianco e nero. C’era sempre un volto noto. Non passava giorno senza che mi raccontasse di aneddoti capitati a questo o a quest’altro, e come e quando li avesse visti l’ultima volta, e se le stavano simpatici o meno. Per me non erano domande indiscrete, tanto più che mi parlava dei defunti con grande serenità, vedendo il mio interesse. Nonostante la sua malattia, che la portava a vedere continuamente la morte ad un palmo dal naso, i suoi occhi di pacata riconoscenza sembravano ringraziare ancora il bel tempo che le rimaneva. Sapeva di avere un debito verso la vita, che, a detta dei medici, le stava concedendo di rivedere fin troppe stagioni, e solo dopo molti anni mi accorsi con quale sforzo si dedicasse nel tentativo di nascondere ai nipoti quell’ombra mortale che la teneva in ostaggio. Non voleva che altri portassero il peso della sua infermità, cosa che la portava a non parlare mai della morte come qualcosa che la potesse toccare, ma come qualcosa di totalmente estraneo a lei. Un valido rimedio contro quel sapore tombale che aveva fra le labbra lo trovò, ancor più che nella chemioterapia, nella ritualità di ogni attività, anche per quanto riguarda il suo rapporto con i defunti. Viveva le sue giornate allo stesso modo di sempre: come sempre, mentre rifaceva i letti, ascoltava lo stesso disco di Lucio Dalla; come sempre, per colazione sgusciava non più di cinque noci; faceva un giro di telefonate ad amiche e parenti, chiamandole sempre secondo il medesimo ordine; come sempre, scendeva sotto casa dal giornalaio, scambiava due monete per un plico di carta, si sedeva alla solita sedia e apriva la gazzetta dal fondo. In tutta questa apparente monotonia era racchiusa la sua forza e la sua resistenza alla malattia. Allora non potevo sapere quale lotta velasse quel tranquillo tran-tran, e mi compiacevo di quella sorta di sensazione di déjà-vu che rivivevo ogni mattina. Ancora sotto le coperte, udivo le prime note di “Balla balla ballerino”, ma non mi alzavo ancora: sapevo di dover aspettare lo scrocchio dei gusci ripetuto per cinque volte, poi ancora il cicaleccio delle conversazioni al telefono fisso, e solo dopo procedevo verso la cucina e la vedevo: la nonna e l’ultima facciata delle necrologie, un tutt’uno paradossalmente rasserenante. Di tutte quelle pratiche consuetudinarie, era inevitabile che quella cui rimanessi più affezionato fosse la consultazione degli annunci funebri, dato che era immediatamente connessa alla vista delle dita nodose della nonna, prima ancora che del suo viso.
Pur essendo passata una decina d’anni, non è che le abitudini siano cambiate più di tanto. Non leggo più il giornale, è vero; mia nonna non mi porge più la tazza di latte, né mi sveglia al suono dei suoi dischi; raramente faccio colazione al bar. Tuttavia, ciascuno di quei rituali si è tradotto in qualcosa di molto simile, adattandosi ai nuovi mezzi di comunicazione. Ora, ricerco quei momenti di trascurabile felicità in alcuni post sui social, dove i morti “Vip” sono annunciati sotto forma di meme.
Ancora oggi, spesso la colazione si accompagna al caffellatte (uno dei pochi privilegi dell’essere adulto, o quasi, è poter aggiungere al latte quella bevanda scura e tanto proibita ai bambini) e ai necrologi “digitali”, se così possiamo chiamarli. Quando poi mi capita sottomano il giornale locale, ancora lo apro partendo dal fondo, benché disinteressato alle identità dei deceduti, come se quella consuetudine mi rimettesse nondimeno in contatto con mia nonna. Si può ben dire che i morti siano la mia madeleine proustiana, senza che nessuno mi accusi di esoterismo o eccentricità- o almeno così spero.
L’unica differenza fra il giornale mattutino cui ero abituato da bambino e l’uso dei social sta nel fatto che, oggi, la notizia di un decesso particolarmente interessante viene diffusa all’istante da almeno una trentina di pagine, fra quelle appartenenti a testate ufficiali (o meno) e quelle destinate alla pura goliardia. Dunque, quel senso di rassicurazione che nei giornali cartacei mi veniva concesso solo alla mattina, potrebbe essere ipoteticamente replicabile a tutte le ore del giorno. E in effetti è così, ma solo in parte. Quando, per esempio, è stata annunciata la morte di Claudia Cardinale, il 10 settembre scorso, erano le 11 di sera passate e mi trovavo steso sul divano a scrollare compulsivamente i reels consigliati. Ad un certo punto la home page si ricarica e fa capolino il solito meme di madonnafreeeda- pagina di cui sono da tempo un aficionado e che sta diventando la principale fonte di informazione in materia di decessi di celebrità anche nella mia cerchia di amici- in cui si mostra rammarico per il fatto che la morte ha colpito ancora una volta la persona sbagliata, al posto di Netanyahu (anche se si tratta di un meme, fa comunque riflettere sul presente con uno sguardo politico e morale insieme). Quelle poche righe di necrologio, se tale si può definire, sono state un soffio di ventilata serenità, in cui la morte aveva perso qualsiasi accezione dolorosa di fronte al ricordo immediato dei pomeriggi passati, sempre al fianco di mia nonna, a guardare i film della compianta attrice. Tuttavia, quello senso rasserenante non è nulla di paragonabile al conforto datomi dall’annuncio funebre di Maurizio Costanzo: non perché Costanzo mi stesse meno simpatico della Cardinale- anzi, sono molte di più le occasioni in cui, mentre mi alzavo a tarda notte per bere un bicchier d’acqua, trovavo la nonna sintonizzata sul “Maurizio Costanzo show” sulla piccola televisione della cucina- ma semplicemente perché Costanzo ha avuto la fortuna (o la sfortuna) di morire in mattinata. Ed è dunque l’epitaffio di Costanzo ad avermi tuffato molto più vividamente in quelle tazzone di latte che la nonna mi scaldava alle 7 in punto, prima di andare a scuola. Mi ha, perciò, piacevolmente sorpreso constatare come sia rimasto pressocché immutato quel tratto d’infanzia che guardava alla morte con giocosa curiosità.
Tutto questo discorso, personalissimo e forse’ anche un po’ delirante, credo mi abbia fatto capire meglio quanto di buono si possa ricavare anche dalla morte, quando la si cali nella quotidianità, talora con ironia- frase alquanto cinica da dire, considerando tutte le tragedie che circondano il presente, ma lasciatemela passare.
Messe da parte tutte quelle favole sul paradiso, trovare conforto dalla notizia della scomparsa di qualcheduno è per me il solo ed unico modo per concentrarmi sul significato che questa persona ha dato alla vita, piuttosto che sulla mancanza di significato che procura nel lasciarla.
Detto questo, non ho che una ventina d’anni, ma mi auguro lo stesso di crepare entro mezzogiorno.
Autore
Niccolò Delsoldato
Potrebbero interessarti:
Dello stesso autore:

/w=1920,quality=90,fit=scale-down)